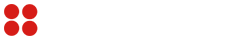Ritorna a p. 1 – 2.1. L’estensione delle persone giuridicamente responsabili
2.2. L’estensione del contenuto della responsabilità
2.2.1. La responsabilità di proteggere gli esseri umani
Non si tratta solo di sapere chi è responsabile, ma di cosa si è responsabili. Utilizzo di proposito l’espressione “responsabilità di proteggere”. Essa è recente nel diritto internazionale, creata come estensione dell’ingerenza umanitaria nei confronti di popolazioni minacciate da crimini quali i crimini contro l’umanità o i crimini di guerra. Questo nuovo concetto è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005 ed è stato utilizzato nel contesto della Libia per legittimare le azioni militari, disciplinate in principio dalle chiare limitazioni imposte nella Risoluzione del Consiglio di sicurezza del febbraio 2011.
Nel 2005, gli Stati hanno riconosciuto la responsabilità di proteggere la propria popolazione da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità. Nel 2009, l’ultima volta in cui l’Assemblea generale si è occupata della questione, il Segretario generale ha delineato una strategia fondata su tre pilastri: la responsabilità di ogni Stato, la responsabilità della comunità internazionale di assistere gli Stati nell’assunzione di tale responsabilità, e, infine, la responsabilità della comunità internazionale stessa di utilizzare tutti i mezzi diplomatici, umanitari e altri mezzi pacifici per proteggere le popolazioni, così come di farsi trovare pronta ad adottare misure collettive. La strategia insisteva sul valore della prevenzione e, nel caso in cui questa non desse risultati, su un intervento “rapido e flessibile” concepito in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso.
Se la costruzione teorica della responsabilità di proteggere appare solida e logica, le sue modalità di applicazione pratica presentano ancora non poche difficoltà. Ammessa in Libia nel 2011, la responsabilità di proteggere è stata poi fortemente criticata, in particolare per l’interpretazione estensiva che ne è stata fatta. Per questo motivo non è stata poi utilizzata in Siria. La sua applicazione non è, dunque, affatto semplice. Nella maggioranza dei casi, peraltro, è lo Stato stesso a muoversi per i propri cittadini, senza ammettere ingerenze da parte della comunità internazionale. Ci si potrebbe quindi chiedere se tale concetto non sia nato già morto, considerando anche, da un punto di vista più formale, il ruolo in materia della stessa Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e del suo Consiglio di sicurezza. Emerge a proposito la questione del diritto di veto dei membri del Consiglio: è attraverso il suo esercizio (e in particolare attraverso i veti cinesi e russi) che la maggior parte delle risoluzioni relative alla Siria sono state bloccate dal 2012. D’altro canto, per il momento, la soppressione di tale diritto di veto non sembra ipotizzabile. Ecco dunque i limiti pratici della responsabilità di proteggere. Ciò non toglie, tuttavia, che tale concetto, fondato sui valori universali espressi dall’ONU, risponde a una idea giusta. Urge pertanto una riflessione più approfondita per rendere le istituzioni dell’ONU più efficaci in materia ed evitare le situazioni troppo frequenti di paralisi istituzionale.Una volta chiarito, sarebbe interessante applicare il concetto “responsabilità di proteggere” a nuovi centri di interesse quali gli animali, l’ambiente naturale e le generazioni future.
Implementazione della responsabilità di proteggere
Rompendo un “silenzio” di circa dieci anni, nel 2018 l’Assemblea generale ha tenuto il suo primo dibattito formale sulla responsabilità di proteggere. Il Segretario generale dell’ONU, António Guterres, in un rapporto intitolato Responsabilità di proteggere: dall’allerta rapida all’intervento rapido, ha proposto una strategia articolata intorno ai tre punti seguenti: rafforzare le capacità di prevenzione esistenti; continuare a promuovere l’obbligo di riferire in materia di prevenzione delle atrocità; innovare, allargando sensibilmente il coinvolgimento della società civile nella prevenzione delle atrocità.
2.2.2. La responsabilità di proteggere gli animali
Per arrivarci, è senza dubbio necessario passare dalla nozione di diritti, che implicano una reciprocità – parliamo di “responsabile” e di “vittima” – a quella di dovere, che impegna senza reciprocità. La distinzione è importante, soprattutto in tema di protezione degli animali – di alcuni animali, essendo la categoria “animale” estremamente eterogenea (non si tratta certo di proteggere i batteri in quanto tali). La questione è interessante: riconoscere dei diritti agli animali, come auspicato da alcuni (si veda la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale del 1978), comporta, a mio avviso, lo stesso rischio di disumanizzazione, in qualche modo al contrario, del rifiuto di alcuni diritti di essere umano a persone che diremmo “incompiute”. D’altro canto, una responsabilità giuridica fondata sul dovere di proteggere gli animali consente di collegare ominizzazione e umanizzazione: l’ominizzazione, perché gli animali sono indispensabili alla sopravvivenza dell’umanità; l’umanizzazione, perché è un dovere che incombe sull’essere umano, essendo il solo capace di coscienza e intenzionalità.
Da qui l’evoluzione del diritto. Il codice penale francese ha aggiunto ai reati contro la persona e contro il patrimonio una nuova categoria in cui figura proprio la protezione degli animali contro sevizie gravi e atti di crudeltà che arrivano fino a quelli di natura sessuale. Ad esempio, con una sentenza del 2007, il proprietario di un pony è stato condannato in sede penale per aver praticato degli atti di sodomia nei confronti di quel povero animale che non poteva, dissero i giudici, «esercitare una qualsivoglia espressione di volontà e viene così trasformato in oggetto sessuale». In modo più ampio e lungimirante, l’Unione Europea fa riferimento alle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri sensibili (si veda il Trattato di Lisbona). Una direttiva del 2010 continua sulla stessa linea in tema di sperimentazione sugli animali. Vi è qui una rottura con la concezione dualista, ma si preserva comunque una differenza tra l’umano e il non umano: è ciò che conta.
2.2.3. La responsabilità di proteggere l’ambiente naturale
Secondo esempio: la responsabilità di proteggere l’ambiente naturale. Essa è attualmente sancita in molte costituzioni; in Francia, si tratta della Carta del 2005. Ogni persona ha il dovere – la parola dovere è rara in un testo di carattere costituzionale – di contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente naturale. Sullo sfondo c’è l’idea dell’essere umano come concessionario del pianeta. Gli strumenti giuridici vanno moltiplicandosi, in particolare dopo il Summit della Terra tenutosi a Rio nel 1992 (biodiversità, cambiamenti climatici). Ne esistono d’altronde molti altri: in caso di conflitto armato, un attacco deliberato contro l’ambiente naturale può costituire un crimine di guerra. Strumento altrettanto nuovo: il concetto di “bene pubblico globale”, che è una sorta di sintesi dell’economia – è un bene collettivo non appropriabile e non rivale – della politica – è un bene pubblico – e dell’etica – è un bene comune. Applicato ai cambiamenti climatici, questo concetto segna un’evoluzione nella necessità di responsabilizzare i titolari del potere globale, cioè di coloro che sono coinvolti direttamente nei cambiamenti climatici, ovvero, in primo luogo, gli Stati e, successivamente, le imprese.
La COP 21: il risveglio della coscienza della nostra comunità di destino
La COP 21 (XXI conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) non è stata né un fallimento né un successo (Torre-Schaub 2017).
Ha rappresentato, in primo luogo, una presa di coscienza. La comunità internazionale ha riconosciuto che il suo destino – come quello di tutti gli esseri viventi di questo pianeta – dipende fortemente dai comportamenti dell’uomo, dal momento che, appunto, lo sconvolgimento del clima è un fenomeno di origine prevalentemente umana. Ha segnato, inoltre, un cambio di metodo. La comunità internazionale ha capito che non è più sufficiente formulare concetti nuovi, come fatto nel secolo scorso con, ad esempio, il “patrimonio comune dell’umanità”, apparso negli anni Sessanta a proposito degli oceani, della Luna e di altri corpi celesti; oppure i “beni pubblici globali” o “beni comuni globali” – concetti presi in prestito dalle teorizzazioni degli economisti negli anni Ottanta (si veda il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo del 1987) per definire quei beni che sono allo stesso tempo non esclusivi (possono essere utilizzati da tutti) e non rivali (il loro uso non ne compromette l’utilizzazione da parte di altri). Queste innovazioni terminologiche non sono riuscite a modificare la gerarchia dei poteri. Il diritto internazionale, infatti, è rimasto un quasi-monopolio degli Stati che difendono i propri interessi nazionali e si ritirano dai trattati quando tale interesse diverge da quello mondiale: basti pensare al Canada, che ha denunciato il protocollo di Kyoto dopo essere stato sanzionato per violazione dei suoi impegni.
Al posto di concetti nuovi, l’accordo di Parigi istituisce un processo per tentare di preservare l’avvenire (e il presente) del nostro pianeta. Non lo si deve leggere come un atto isolato, separato dal movimento in cui si inscrive, e senza il quale non esisterebbe: fa parte di un processo dinamico che deve pertanto essere regolarmente aggiornato. Attualmente, l’accordo del 15 dicembre 2015 non rappresenta un oggetto giuridico sufficientemente unificato e stabilizzato da dare luogo a un insieme coerente di norme, forme e dogmi. Le norme emergono nel più grande disordine e si accumulano a tutti i livelli (internazionale, mondiale o regionale, nazionale, infra-nazionale).
Combinato a un ammorbidimento delle forme a favore di un diritto interattivo ed evolutivo assai complesso, l’eccesso di norme contribuisce all’allentamento dei dogmi che credevamo eterni quali l’indipendenza degli Stati, sovrani assoluti nel loro territorio. Si può capire lo sgomento dei giuristi.
E, ciononostante, l’accordo di Parigi è una magnifica scommessa sull’avvenire. La dinamica che produce non è sempre “virtuosa”, ma invita a ricomporre il campo giuridico e cerca di costruire il futuro combinando l’uno e i molti secondo un movimento in tre tempi: definizione di obiettivi comuni, differenziazione delle responsabilità secondo gli Stati e, infine, diversificazione degli attori con aumento della forza di quelli non statali.
2.2.4. La responsabilità di proteggere le generazioni future
Quando si giunge al terzo esempio di quelli che ho chiamato “i nuovi centri di interesse”, ovvero alle generazioni future, il processo diviene ancora più complesso. Tale formulazione è in effetti talmente vaga che l’impostazione giuridica varia a seconda della lontananza nel tempo. Per “generazioni future” si intendono le generazioni che non sono destinate a incontrarsi: non i nostri figli o nipoti, ma quelli che verranno dopo di loro. C’è in questo caso un dovere di protezione che ci impegna senza reciprocità, ma che impone allo stesso tempo di anticipare i rischi futuri.