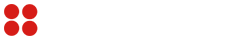Continua dalla pagina precedente
Claudio Tolomeo, astronomo, oltre che astrologo e geografo greco, vissuto circa 300 anni dopo Ipparco, in quella straordinaria fucina culturale che fu Alessandria d’Egitto, all’epoca in cui quest’ultima era già parte dell’Impero Romano, migliorò la precisione del modello di Ipparco, sostituendo all’eccentrico l’equante. In questo nuovo modello, che egli descrisse accuratamente in un’opera monumentale, che portava il titolo di Mathematikè sýntaxis, ovvero Trattato matematico, il centro del deferente non coincideva né con la Terra, né con l’eccentrico, ma si trovava in un punto, l’equante, che per tutti i pianeti, a eccezione di Mercurio, era collocato esattamente a metà fra la posizione della Terra e quella del pianeta. Soltanto dall’equante il moto del centro dell’epiciclo sul deferente appariva come circolare uniforme, ma non esisteva alcuna giustificazione per questo artificio, che era esclusivamente di carattere geometrico, se non il tentativo di riprodurre al meglio le posizioni osservate dei pianeti e Tolomeo riuscì nel suo intento.
Il corso degli eventi della storia, tuttavia, rese il Mathematikè sýntaxis del tutto sconosciuto in Europa per circa mille anni, fino a quando gli astronomi arabi che lo avevano letto, tradotto, utilizzato e apprezzato a tal punto da modificarne il titolo in al-Magisṭī, ossia Il Grandissimo, non avrebbero portato il manoscritto in Spagna. Fu qui – e più precisamente nella città di Toledo che, dopo essere stata strappata nel 1085 da re Alfonso VI di Castiglia a un dominio arabo durato quasi 400 anni, era divenuta un centro culturale multietnico, ricchissimo di biblioteche e di testi in lingua araba – che un italiano, Gherardo da Cremona, tradusse intorno al 1160 l’opera di Tolomeo dall’arabo al latino, latinizzandone anche il titolo in Almagestum. Ottant’anni dopo, John of Holywood, meglio noto come Giovanni Sacrobosco, matematico, astronomo e astrologo (nato probabilmente in Inghilterra nel 1195 e morto a Parigi, dove insegnava all’università), avrebbe tratto da questa traduzione dell’Almagesto quello che per molti anni sarebbe stato il manuale di astronomia più diffuso nelle università d’Europa: il Tractatus de sphaera (noto anche come il De sphaera mundi, o più semplicemente come il De sphaera).
La traduzione a opera di Gherardo da Cremona sarebbe rimasta l’unica versione nota dell’Almagesto in Europa fino a quando, con l’avvento dell’Umanesimo, non si sarebbero avviati un intenso lavoro di promozione e riscoperta dei “classici” e una conseguente traduzione dei testi originali dal greco al latino, che avrebbero avuto come effetto la rapida diffusione del modello di Tolomeo.
Una sorte simile a quella di Tolomeo aveva subìto anche Aristotele, il cui pensiero aveva iniziato a diffondersi in Europa alla fine del XII secolo per effetto dei commenti di Ibn Rushd, a noi noto come Averroè, medico, filosofo e matematico arabo, nato a Cordova, in Spagna, nel 1126, e morto a Marrakech, in Marocco, nel 1198. L’accoglienza nei confronti del filosofo greco non era stata proprio delle migliori: nel 1210, nella nascente Università di Parigi, la lettura e l’insegnamento delle opere naturali di Aristotele e dei commenti a esse dedicate erano stati proibiti, pena la scomunica, e quando, nel 1252, un giovane e dotto frate domenicano, Tommaso d’Aquino, era giunto in quella città in veste di professore dell’università, vigeva ancora il divieto assoluto di commentare le opere di Aristotele.
Il giovane frate, tuttavia, non si era arreso e, non avendo studiato il greco, aveva chiesto a un confratello belga, Guglielmo di Moerbeke, di tradurre tutte le opere originali di Aristotele in latino. In questo modo, aveva potuto commentarle e anche evidenziare ogni singolo passaggio in cui la traduzione attraverso l’arabo non era coerente col testo originale.
Il lavoro di Tommaso non si fermò qui, perché egli attuò anche una completa rivalutazione del filosofo greco, cogliendo, in particolare nella sua cosmologia, la prova evidente dell’esistenza di Dio: il motore immobile. Concetto che, del resto, era stato introdotto proprio dallo stesso Aristotele nella Metaphysica.
Grazie a questa rilettura del filosofo della natura greco, effettuata da san Tommaso, il modello geocentrico, che già godeva della totale approvazione dei teologi, perché pareva impensabile che Dio non avesse voluto porre al centro dell’Universo l’Uomo, termine ultimo della sua creazione, acquisiva una propria sacralità. In quel moto ordinato e perfetto delle sfere era possibile, infatti, cogliere il riflesso di Dio, di quell’«amor che move il Sole e l’altre stelle», la cui rapida visione avrebbe fatto perdere i sensi a Dante al termine del suo viaggio immaginario attraverso un Paradiso, in cui il livello di beatitudine delle anime cresceva all’aumentare della distanza dalla Terra, salendo verso l’alto, di sfera in sfera. Queste ultime, in accordo con quanto aveva scritto Aristotele nel De Caelo, erano costituite di una materia cristallina ingenerata, eterna, incorruttibile, imponderabile e perfettamente trasparente: l’etere.
Il modello di Aristotele, approvato e adottato da san Tommaso, tuttavia era una costruzione caratterizzata da un aspetto più teoretico che pratico: i calcoli per determinare le posizioni dei pianeti erano effettuati dagli astronomi utilizzando il modello di Tolomeo, che veniva insegnato in tutte le università d’Europa attraverso l’esemplificazione che ne era stata proposta da Sacrobosco nel De sphaera. Gli studiosi erano consapevoli che il sistema geocentrico di Tolomeo mostrava diversi problemi, il più grave dei quali era la mancanza di una variazione osservata del diametro della Luna. Quest’ultimo, infatti, avrebbe dovuto raddoppiare e dimezzarsi a ogni mezzo giro della Luna sul proprio epiciclo, che Tolomeo aveva dovuto rendere particolarmente grande per riuscire a riprodurre, con buona precisione, le posizioni osservate della Luna. Inoltre, tutti i diversi artifici su cui si fondava il modello di Tolomeo, ossia le dimensioni relative di epicicli e deferenti, le velocità di rotazione a loro assegnate e gli equanti, non avevano alcuna giustificazione, se non quella di tentare di conciliare, al meglio, le predizioni con le osservazioni.
Nessuno, tuttavia, osava mettere in dubbio un modello che era stato ritenuto valido per più di mille anni e soprattutto godeva della totale approvazione della Chiesa. Qualcosa, però, stava cambiando in quella nuova era, che si era aperta con l’invenzione della stampa, a cui avrebbero fatto seguito appena 40 anni dopo la scoperta dell’America e l’inizio di un’epoca di grandi navigazioni.
I viaggi attraverso l’oceano, oltre a necessitare di riferimenti astronomici precisi per l’orientamento, cominciavano a mostrare la presenza di terre e di popoli anche in quella parte del globo non considerata né nella Bibbia, né dallo stesso Alighieri che aveva illustrato con maestria poetica, nel XXXIV Canto dell’Inferno (vv. 121-126), la ragione per cui tutte le terre emerse dovevano trovarsi solo nell’emisfero boreale:
Da questa parte cadde giù dal cielo;
e la terra, che pria di qua si sporse,
par paura di lui fé del mar velo,
e venne a l’emisperio nostro; e forse
per fuggir lui lasciò qui loco vòto
quella ch’appar di qua, e su ricorse.
Chi è caduto dal Cielo, in direzione della parte meridionale della Terra, è Lucifero, l’angelo ribelle. Allora, per paura, le terre di quell’emisfero si sono ritirate verso l’alto, lasciandolo interamente ricoperto dalle acque e poi, quando Lucifero è giunto a conficcarsi nel centro della Terra, anche le terre che si trovavano sopra di lui sono fuggite verso l’alto, creando così il vuoto della voragine dell’Inferno. Fuoriuscite dall’emisfero settentrionale, le terre si sono spostate in quello meridionale, dove hanno formato la montagna del Purgatorio, proprio quella stessa che Ulisse aveva dichiarato di essere riuscito a intravedere, nel XXVI Canto dell’Inferno (vv. 133-135), dopo aver varcato assieme ai suoi compagni le Colonne d’Ercole ed essersi spinto nell’emisfero australe:
quando n’apparve una montagna,
bruna per la distanza, e parvemi alta
tanto quanto veduta non avea alcuna.
Una visione rapida, subito seguita dalla tragedia (vv. 136-142), a cui va inevitabilmente incontro chiunque osi dirigersi verso l’altro emisfero, nel tentativo di conoscere ciò che non è dato all’uomo di sapere:
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,
ché de la nova terra un turbo nacque,
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar con la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,
infin che’l mar fu sovra noi richiuso.
In questo XXVI Canto dell’Inferno, Dante interpreta mirabilmente la concezione ancora dominante nel Medioevo che vede l’uomo come creatura di Dio, a cui è preclusa, pena la punizione eterna, ogni tipo di attività che sia frutto di una scelta personale e che vada in conflitto con la volontà prestabilita dal Creatore: il Dio che punisce Ulisse per la sua sete di conoscenza è ancora molto simile al Dio che ha condannato Adamo ed Eva ai patimenti della vita terrena per un peccato analogo. Non erano trascorsi 200 anni dalla stesura della Divina Commedia, che il mondo aveva iniziato a cambiare e, cinque anni dopo la scoperta dell’America, giungeva a Bologna un giovane polacco. Chi lo aveva inviato a frequentare quello che era considerato lo Studium più prestigioso dell’epoca era stato lo zio materno, Lucas Watzenrode, che lo aveva cresciuto assieme ai suoi tre fratelli, quando, poco più che bambini, erano rimasti orfani del padre. Lo zio era il vescovo di Warmia, una diocesi nella regione nord-orientale della Polonia, ed era riuscito a strappare ad alcuni ecclesiastici influenti la promessa che il nipote avrebbe ottenuto la nomina a canonico della regione di Frombork, di cui Warmia faceva parte. Si trattava di un incarico a carattere amministrativo, che non richiedeva il sacerdozio, ma una formazione universitaria di giurisprudenza e di diritto canonico. Per questo motivo, dopo aver compiuto i primi studi e appreso il latino a Cracovia, il giovane era stato mandato dallo zio a Bologna. Qui aveva imparato il greco e trovato alloggio presso un illustre insegnante: Domenico Maria Novara (detto anche da Novara), di origine ferrarese, che dal 1483 era professore di matematica e astronomia all’Università.