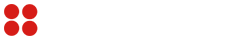Nel suo scritto del 1946 Sartre sosteneva che «la parola umanismo ha due sensi molto differenti». Da un lato l’umanesimo è «una dottrina che considera l’uomo come fine e come valore superiore», dall’altro invece l’umanismo consisterebbe nel pensare l’uomo come «costantemente fuori di se stesso». Nel primo senso l’umanismo non solo “è assurdo”, nella misura in cui presuppone la possibilità per il singolo di formulare «un giudizio complessivo dell’uomo», ma lo è ancor di più perché è la base di un «culto dell’umanità» che «mette capo all’umanismo chiuso in se stesso di Comte e, bisogna pur dirlo, al fascismo». Nella seconda accezione, invece, l’umanismo, ponendo una «connessione fra la trascendenza come costitutiva dell’uomo […] e la soggettività», è «esistenzialista» (Sartre 1946, p. 85-861Sartre J.-P. (1946) L’esistenzialismo è un umanismo, Milano: Mursia.).
La connotazione umanistica dell’esistenzialismo denota, per Sartre, il carattere di una «dottrina d’azione» che pone all’uomo il compito di cercare «fuori di sé uno scopo, – che è quella liberazione, quell’attuazione particolare» attraverso cui l’uomo «si realizzerà precisamente come umano» (Sartre 1946, p. 86). Sartre s’interroga sul senso complessivo del concetto di “umanismo” ponendo una questione decisiva: quella della concezione di un “culto dell’umanità”, opposta al riconoscimento della valenza dell’agire umano sgombro da ogni trionfalismo. In questo modo la riflessione di Sartre tocca un problema centrale sia per capire il senso della domanda sulla “modernità” implicita allo studio dell’umanesimo, sia per cogliere la profonda ambiguità che avvolge l’idea di libertà nel pensiero moderno, nel suo essere sospesa tra un’esortazione quasi tragica all’azione e l’autoaffermazione celebrativa dell’uomo.
Nella Lettera sull’“umanismo” del 1947 con cui rispondeva a Jean Beaufret in merito alle questioni sollevate dalla celebre conferenza di Sartre, Heidegger scriveva che «è al tempo della Repubblica romana che l’humanitas viene per la prima volta pensata e ambita esplicitamente con questo nome». L’umanesimo è il prodotto dell’assimilazione latina della παιδεία dei Greci, tradotta come humanitas. Per questo, secondo Heidegger, «nella sua essenza l’umanesimo resta un fenomeno specificatamente romano»; pertanto «il cosidetto Rinascimento del XIV e del XV secolo in Italia è una renascentia romanitatis» nella quale «la grecità viene sempre considerata nella sua forma tarda e questa in modo romano» (Heidegger 2002, p. 2742Heidegger, M. (2002) Lettera sull’«Umanismo», Milano: Adelphi.). L’argomentazione di Heidegger si arti-cola su due piani. Il primo è quello di un «umanesimo storicamente inteso», romano, che pone tratti comuni tra la renascentia italiana del Quattro e Cinquecento e il classicismo di Winckelmann, Goethe e Schiller. Significativa, al proposito, l’esclusione di Hölderlin, che «non appartiene a questo “umanismo”, perché pensa il destino dell’essenza dell’uomo in modo più iniziale di quanto non possa fare questo umanismo». Il secondo piano è quello in cui «per umanismo si intende in generale la preoccupazione che l’uomo diventi libero per la sua umanità, e trovi in ciò la sua dignità». Da questo punto di vista, scrive ancora Heidegger, possiamo considerare come sia l’umanesimo storico, sia quello di Marx, di Sartre o del cristianesimo «presuppongano come evidente l’“essenza” universale dell’uomo», intendendo l’uomo come “animal rationale”, come “persona”, o come composto di spirito, di anima e di corpo. Ciò nondimeno, «le supreme determinazioni umanistiche dell’essenza dell’uomo non esperiscono ancora l’autentica dignità dell’uomo»: si tratta quindi di pensare “contro l’umanismo” nella misura in cui l’umanismo stesso non pone «l’humanitas dell’uomo a un livello abbastanza elevato». La definizione del valore dell’uomo e della sua libertà può avvenire solo su un piano diverso da quello della valutazione fondata su di una particolare determinazione metafisica dell’uomo. Per Heidegger ciò significava evitare la soggettivazione implicita a ogni valutazione, ponendosi a un livello diverso da quel “pensare per valori” che è «la più grande bestemmia che si possa pensare contro l’essere» (Heidegger 2002, p. 301).
Nell’articolo Mezzo secolo dopo, del 1998, a proposito del contesto culturale nel quale era maturato il suo libro, Garin ricordava di come «Parigi proprio in quel momento fosse piena delle discussioni estremamente vivaci suscitate dalla celebre conferenza di Sartre al Club Maintenant» (Garin 1990, p. 1533Garin, E. (1990) La filosofia come sapere storico, Roma-Bari: Laterza.). Secondo Garin, Sartre, per precisare la propria concezione filosofica, andava ripetendo, quasi alla lettera, certe posizioni di un umanista «che ateo certo non era e non si proclamava, ma che con rara efficacia aveva posto la peculiarità dell’uomo nel suo essere un punto di assoluta libertà della propria natura: Pico della Mirandola». Cinquecento anni prima di Sartre, notava Garin, sull’idea che l’uomo fosse «l’avvenire dell’uomo», qualcosa di indefinibile, un punto di libertà che forma se stesso, Pico aveva costruito la sua celebre Oratio. Per questa ragione, scriveva ancora Garin, «a guardar bene a fondo, l’umanesimo ateo di Sartre e l’umanesimo di Pico (col suo sfondo ermetico-cabbalistico) non erano nella sostanza troppo lontani, mentre era davvero tutt’altra cosa l’umanesimo di cui Heidegger discuteva con Beaufret» (Garin 1990, p. 154).
Il rapporto di Garin con la filosofia di Heidegger è particolarmente interessante. Garin conosceva molto bene i testi di Heidegger e, a distanza di anni, scriverà di non poter dimenticare l’impressione di quelle letture, dalle quali però si era allontanato. Alla fine degli anni Novanta ricordava di essere rimasto particolarmente colpito dal giudizio di Löwith su Heidegger, secondo il quale la «presa di posizione a favore del nazionalsocialismo era insita nell’essenza della sua filosofia […] per quel radicalismo col quale fonda la libertà dell’esistenza propria di ciascuno […] sullo stato di rivelazione del nulla». Ciò che Garin difendeva, scrivendo dell’umanesimo, non era solo un’idea diversa del fare filosofia, e quindi un modo diverso di rapportarsi all’umanesimo, ma era una concezione filosofica dell’uomo opposta, strettamente legata all’idea gramsciana di una storia intesa «come prodotto della libera attività intelligente dell’uomo», ben diversa dalla convinzione che leggeva in Heidegger, secondo cui «l’uomo moderno, dal Rinascimento in poi, è maturo per essere seppellito» (Garin 1997, p. 47).
Nel 1968, nell’articolo Quel Humanisme? Garin aveva comunque riconosciuto due grandi meriti allo scritto di Heidegger. Da una parte quello di «avere fortemente sottolineato l’usura del termine umanismo»; dall’altra quello di avere compreso come la discussione tra un umanismo “storico” (del Rinascimento e del dopo Rinascimento) e un umanismo “teorico” non fosse qualcosa di sterile, ma segnasse piuttosto, in entrambi i casi, un confronto tra diverse «concezioni dell’uomo e del suo destino» (Garin 1968, pp. 265-266). L’argomentazione di Garin procedeva dalla convinzione che l’umanesimo italiano fosse filosofia; una filosofia certamente più ampia, capace di includere anche esperienze intellettuali e autori non canonici, ma protagonisti di un movimento culturale che non poteva in alcun modo essere ridotto, come per Kristeller, a «quella parte della scienza e della cultura che ha il suo centro negli studi grammaticali e retorici, cioè letterari» (Kristeller 1962, p. 3834Kristeller, P. O. (1962) Umanesimo filosofico e umanesimo letterario, Lettere italiane, XIV(4): 381-394.). A Heidegger, scriveva Garin, «gli umanismi appaiono condannati a morire d’asfissia nel vuoto del soggettivismo metafisico, e a perdersi nell’oblio dell’Essere». L’umanesimo storico, quello sviluppatosi in Italia tra il Quattro e il Cinquecento, fu certamente “rammemorazione”, ma non dell’Essere, quanto di «una visione umana del mondo», di un ritorno all’esperienza e alle culture degli uomini tra uomini (Garin 1968, p. 270).
La concezione di Heidegger dell’umanesimo storico come affermazione del soggettivismo metafisico si legava, nel pensiero di Garin, all’idea husserliana che poneva nel Rinascimento l’origine di un dualismo insuperabile tra natura e mondo psichico. Per Garin si trattava di una “doppia alienazione”: Heidegger, da una parte, e Husserl, dall’altra, leggevano nel Rinascimento l’origine di una frattura tra l’uomo e se stesso e tra l’uomo e la natura dalla quale faceva nascere la “modernità”. La Krisis husserliana in particolare, alla cui lettura Garin era stato sollecitato anni prima dalle lezioni di Francesco De Sarlo, se da un lato rappresentava l’«atto di accusa contro quella crisi del pensiero occidentale che era culminata nel nazismo», dall’altro poneva problemi cruciali a chi si occupasse di Rinascimento (Garin 1990, p. 126).
Se il destino della “modernità” doveva essere Auschwitz, allora all’origine del moderno vi era qualcosa di molto più complesso e di molto diverso dal luminoso affresco del Burckhardt. «Nella diagnosi della crisi – scriverà Garin – sembrava profilarsi una condanna convergente di ciò che Burckhardt aveva considerato come le due grandi scoperte del Rinascimento: l’uomo e il mondo, la libertà dell’uno e le leggi dell’altro» (Garin 1968, p. 269). La “doppia alienazione” che separa l’uomo dalla natura e da se stesso, ipostatizzandolo in un’essenza metafisica, nasce dall’inconciliabilità della libertà umana con l’esigenza scientifica dell’ordine razionale di tutte le cose e il problema della modernità viene a saldarsi profondamente con quello della libertà. La conclusione di Garin in Quel Humanisme? rispondeva alla domanda su «cosa è veramente stato, nelle sue aspirazioni filosofiche essenziali, questo umanismo “storico”, così spesso messo in questione, anche se quasi sempre senza grande rigore (e senza grande conoscenza storica)» (Garin 1968, p. 271). Lo studio puntuale dei testi, il riportare alla luce pagine e opere spesso completamente sconosciute, il metodo storico con il quale Garin ha lavorato per decenni sul Rinascimento permettevano di «dare altro colore al volto di un secolo» (Garin 1990, p. 138). La filosofia dell’umanesimo storico non andava nella direzione di una definizione metafisica della “natura” umana. Per Pico, ribadiva Garin, una natura umana non esiste. E proprio per questo l’uomo ha un progetto e non un destino: la sua indeterminatezza significa libertà. Nel rapporto con la natura poi l’uomo «diviene cosciente della sua finitezza e della sua fragilità, scoprendo l’infinità del mondo fisico […] e applicando conseguentemente all’universo una visione pluralista e relativizzante» (Garin 1990, pp. 272-273).