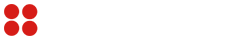8. Concordia discors
Se non esiste, o non è dato conoscere, un itinerario teleologicamente segnato nella storia del mondo, se il punto sommo della conoscenza umana consiste nel riconoscere in sé lo squilibrio stesso dell’universo, se concordia e armonia sono l’esito di un percorso di sapienza che procede dalla coscienza del limite, dall’impossibilità di cogliere alcunché di assoluto e definitivo e dalla necessità conseguente di costruire un edificio del sapere su prospettive consapevolmente parziali, provvisorie, congetturali, esiste, al di là e al di sopra della concordia discors della ragione e della volontà umana, un ordine in natura che trasformi la materia disordinata in un cosmo armonico e ordinato? Qual è l’architetto – se c’è – che ha progettato la perfetta macchina del cosmo? E se quest’ordine esiste, l’uomo ha la possibilità di comprenderlo e di adeguare il proprio agire morale alle leggi naturali delle cose?
Gli interrogativi di Pico erano quelli posti, pochi anni prima, da Leon Battista Alberti, il quale, nel De Iciarchia, era stato molto chiaro: «la natura per sé mai errò, mai errerà» (Alberti 20131Alberti, L. B. (2013) Opere, Edizioni La Biblioteca Digitale.). È interessante notare come anche per lui il problema stesse esattamente nella relazione tra il linguaggio, il tempo e le cose: «el favellare – scriveva nel secondo libro del De Iciarchia – per sua natura mostra l’ordine delle cose passate, e rende la ragione delle pre-senti» (Alberti 2013). Sulla questione Alberti ritornerà anche nel Theogenius, ma con toni più pessimistici: «e quello che la natura propio e divino suo dono atribuì a’ mortali per agiungerli a cara insieme benivolenza e dolce pace, el favellare, lo uomo pessimo l’adopera in disturbare qualunque grata congiunzione e offirmata grazia» (Alberti 2013). Diversamente dall’Alberti del De re aedificatoria, per il quale la natura è in sé sempre «absolute perfetta» (Alberti 1989, p. 1012Alberti, L. B. (1989) De re aedificatoria libri decem. Traduzione di G. Orlandi. Introduzione e note di P. Portoghesi. Milano: Il Polifilo.), Pico nega al mondo fisico alcuna vera perfezione: perfetto è solo il mondo intellegibile, perfette sono le idee che governano il tutto e la natura di questo mondo non è altro che un equilibrio instabile di parti.
Questo tuttavia non gli impediva di pensare a un ordine fisico retto comunque da regole precise, né di assumere l’imperfezione della natura quale conditio sine qua non della sua bellezza. Nell’Heptaplus il mondo fisico deriva da «una comune mescolanza regolata tuttavia da norme» (Pico 1942, p. 217), da un’unione di materia e forma provvisoria e temporale, ma ordinata e non casuale. È la stessa logica secondo cui, nel Commento, Pico definisce la natura citando Eraclito e Omero: «diceva Eraclito la guerra e la contenzione essere padre e genetrice delle cose; e, appresso Omero, chi maladisce la contenzione è detto aver bestemmiato la natura» (Pico 1942, p. 495). L’idea di natura come eterna lotta tra gli elementi che formano i corpi non esprime soltanto l’eterno mutare e corrompersi del mondo fisico; è piuttosto la premessa necessaria per pensare a una «proporzionata commistione» tra le parti e quindi a una «amica inimicizia» che segna il passaggio dalla materia senza forma a un cosmo ordinato. «La bellezza – scriveva Pico nel Commento – include in sé qualche imperfezione, cioè lo essere composto in qualche modo» (Pico 1942, p. 495), ma in questo senso, allora, la bellezza propriamente detta appartiene solo al mondo umano e alla natura, ma non a Dio.
La concorde discordia tra le parti però non può realizzare che equilibri provvisori in un circolo nel quale le regole stesse che strutturano il mondo fisico – come risulta nell’Heptaplus – lo configurano come perenne «vicissitudine di vita e morte» (Pico 1942, p. 185). Ecco allora che l’ordine della natura, intesa come armonia che nasce dal conflitto, intreccia il problema del tempo: il tempo della natura, a proposito del quale Pico accenna ai rischi di equilibri strutturalmente sul punto di infrangersi, ma anche il tempo dell’uomo, troppo breve per comprendere l’ordine della natura e troppo incerto per sottrarsi ai rischi del caso e della libertà.
Qual è il posto e la funzione dell’uomo di fronte ai fragili equilibri dell’«amica inimicizia»? E in che modo l’uomo può comprendere l’ordine perfetto della natura o addirittura modificarlo e distruggerlo? Dal tempo umano scaturisce il conflitto tra natura e volontà, tra l’ordine del cosmo e la libertà. Il «divino camaleonte» dell’Oratio e il pipistrello delle Disputationes hanno in comune un abisso e quell’abisso è il tempo. Come Alberti, anche Pico cita i versi di Pindaro: gli uomini sono «creature d’un giorno», «epàmeroi», sogni di un’ombra (Pindaro, Pitica VIII). Pico ne accenna nel Commento per descrivere la condizione terrena dell’uomo; Alberti, in una straordinaria pagina del Theogenius, capovolge il verso per asserire che l’uomo sia «quasi umbra d’un sogno» (Alberti 2013).
La consapevolezza della temporalità trasforma l’uomo nell’ombra di se stesso, nell’inconsistenza del riflesso di un sogno, ed è precisamente questa trasfigurazione dell’umano posto di fronte alla propria temporalità ciò che rende tutto incerto e indefinito. Incerta e indefinita è la storia del pensiero umano, che per Pico resta sempre nascosta dietro ai veli degli antichi miti, dietro alle parole dei poeti, dietro alla complessa simbologia della cabbala e dei testi sacri. Incerta è la conoscenza che l’uomo può avere di se stesso, vale a dire di un essere che non possiede un’essenza definibile, ma che contiene in sé l’abisso indefinito di tutte le possibilità dell’essere. Infine è incerta la conoscenza che l’uomo ha della natura, perché i tempi della natura superano le capacità della razionalità umana e dei suoi linguaggi. «Ogni indagine – si legge nelle Disputationes – di qualunque fenomeno si occupi, afferra piuttosto il verosimile che non il vero» (Pico 1946, p. 1033Pico, G. (1946) Disputationes adversus astrologiam divinatricem. Edizione a cura di E. Garin. Firenze: Vallecchi.); posto in un mondo di apparenze, è il soggetto che interpreta la realtà costruendo relazioni verosimili tra i fenomeni. Questo è anche il senso del paragrafo del De pictura, nel quale Alberti tratta della comparazione. Non esiste una realtà univoca da rappresentare, ma è l’artista a instaurare, tra i vari elementi della composizione, il tipo di relazione più funzionale alla raffigurazione (Alberti 2013). Il filosofo fa la stessa cosa comparando tra loro tutte le tradizioni filosofiche per reinterpretarle e ricollocarle all’interno di un quadro più generale, quello della concordia philosophorum nel quale gli elementi di ognuna si armonizzano in una nova philosophia intesa come riformulazione e ricomposizione del passato. Non crea un nuovo ordine dal nulla, ma rielabora e riformula le proporzioni e i rapporti di forza tra le parti (Angelini, Caye 2007, p. 644Angelini, A., Caye, P., a cura di (2007) Il pensiero simbolico nella prima età moderna, Firenze: Olschki.) e la condizione che permette di farlo è la libertà; ed è proprio a partire dall’istanza etico-morale della libertà che Pico mette radicalmente in discussione la visione aristotelico-tolemaica del cosmo.
Per rivendicare la libertà dall’influsso dei pianeti e dall’astrologia, Pico sostiene, nelle Disputationes, che l’uomo non possa essere schiavo degli influssi celesti, perché gli influssi astrali non sono cause universali e gli unici segni davvero osservabili sono legati solo alla luce, al moto e al calore, elementi, questi, che certamente influenzano il mondo fisico, ma che in nessun modo possono mettere in discussione il libero arbitrio (Pico 1946, pp. 176-178). Come si è visto, si tratta in primo luogo di un problema di metodo: se anche vi fossero altri elementi celesti capaci di agire sulla realtà umana, l’astrologia non avrebbe gli strumenti per prevederli. Il ragionamento di Pico sul metodo è strettamente legato alla prospettiva storica entro la quale si colloca tutta la sua critica all’astrologia: la storia falsifica non solo i pronostici dell’astrologia, ma mina anche lo statuto epistemologico di ogni conoscenza astronomica:
i moderni affermano l’esistenza di così numerosi e così vari movimenti dei corpi celesti, ignoti com’essi credono agli antichi, ed afferrati finalmente da una lunga e costante osservazione. Ebbene, il loro esempio rende manifesta la possibilità che altri moti ancora siano celati agli astronomi, o per la loro lentezza, o per la loro oscurità, o per altra ragione che i posteri un giorno conosceranno attraverso ulteriori osservazioni (Pico 1946, p. 227).
I tempi e la vastità del cosmo si scontrano con i limiti dell’osservazione umana e, storicamente, molte verità dell’astronomia sono state distrutte proprio perché l’oggetto di studio è tale da escludere qualsiasi conoscenza certa. È in questo senso che Pico scuote le basi della cosmologia aristotelico-tolemaica trasformando il problema della struttura dell’universo in quello delle capacità umane di comprenderlo, per arrivare alla conclusione che nessun sistema cosmologico elaborato dall’uomo potrà mai essere esaustivo e perfetto. Dopo aver discusso le ipotesi di Tolomeo, Giovanni di Sassonia, dell’astronomo arabo Albohazen Haly e di Leone Ebreo sulla possibilità di ammettere otto, nove o dieci sfere, Pico conclude affermando che «noi abbiamo riferito tutte queste ipotesi per affermare che, su tale argomento, nulla si può sostenere di certo e di indubitato, poiché ogni discussione termina in posizioni probabili e mutevoli» (Pico 1946, p. 235). Probabile e mutevole è dunque la conoscenza umana del cosmo e della natura e non lo è solo per la vastità dell’oggetto e la difficoltà dell’osservazione, ma anche perché il soggetto stesso che la realizza – l’uomo – è costitutivamente mutevole e in divenire.
L’uomo di Pico, nel suo essere piena indeterminatezza, da una parte è un punto di rottura nell’ordine della natura, dall’altra ne è sintesi e termine di unione. Posto che la natura sia un susseguirsi di equilibri provvisori, un’alternanza di forme e mescolanze nella cui proporzione si realizzano una bellezza e un ordine destinati a dissolversi e probabilmente a ricomporsi in altre forme, l’uomo è l’elemento che realizza il senso di questo fluire, comprendendolo in sé e fissandolo. Il «divino camaleonte» di Pico non ha essenza fissa, altrimenti non potrebbe in alcun modo ricomprendere in sé una realtà multiforme e sfuggente. Adamo e Narciso, entrambi dall’essenza indefinita e impenetrabile, l’uno «straordinario scultore» di se stesso (Pico 1942, p. 107), l’altro intento ad «abbracciare con arte quella superficie del fonte» (Alberti 2013). Adamo che può smarrire se stesso nelle apparenze e mutarsi in bestia, Narciso trasformato in fiore nell’istante in cui viola il velo che separa l’uomo dalla conoscenza di se stesso. È una forma tragica di libertà che li accomuna e li condanna alla metamorfosi: entrambi devono affacciarsi sull’abisso della conoscenza di sé con il solo scopo di ordinare, fissare e ricomprendere una realtà che senza il loro sguardo non avrebbe ragione d’essere.
Spirito e natura, mondo intelligibile e mondo fisico, pensiero e materia si «armonizzano» nell’uomo «che ha in sé il fondamento della loro pace» e che può esprimersi nell’arte e questo perché «la natura spirituale del tutto non si può pensare congiunta ai corpi se non come l’arte, è nella mente dell’architetto, si congiunge al cemento, al legno, alle pietre» (Pico 1942, p. 315). Allo stesso modo, l’uomo che non sia «in pace con se stesso», l’uomo lacerato nella scissione tra corpo e spirito – trascinato nella carne come il bruto dell’Oratio – insieme a se stesso distrugge l’armonia che è chiamato a realizzare. Il peccato, la violazione dell’ordine, il venir meno dell’uomo al proprio compito – quello di essere punto di sin-tesi tra mondo intelligibile e mondo fisico – non colpisce soltanto l’uomo: nel momento in cui l’uomo rompe la relazione con la quale comprende in sé tutti i gradi della realtà, l’ordine stesso della natura è violato: «nei libri dei Profeti – scrive Pico sempre nell’Heptaplus – quando si riporta un comando o un divieto di dio, si invocano a testimoni il cielo e la terra, poiché la violazione della legge offende anche loro» (Pico 1942, p. 307).
Attraverso l’uomo il mondo sensibile comunica e si fonde con quello intelligibile, la realtà corporea, colta con i sensi dall’uomo, riordinata dalla ragione e reformata dall’immaginazione, risplende nella forma pura dell’idea nell’intelletto umano. Allo stesso modo l’idea astratta prende consistenza e oggettività nell’opera d’arte nella quale l’idea artistica si esprime. Questa fusione tra natura e spirito si realizza per opera dell’uomo, a patto che l’uomo scelga di usare la propria libertà per realizzare completamente se stesso. L’uomo che scelga di essere bestia o pianta deve rinunciare alla piena umanità per limitarsi a esprimere solo ciò che lo accomuna agli animali o alle piante: rompe l’ordine naturale delle cose e spezza quella fusione tra spirito e materia sulla quale si fonda l’armonia del tutto e la bellezza del cosmo. Per questo non soltanto Dio, ma anche la natura e i cieli dovranno vendicarsi di lui, perseguitandolo e costringendolo a vivere «come quelli che si aggirano intorno alla terra e al mare e sempre vengono puniti dalla sferza divina. Questi fulmina e perseguita il cielo, questi la terra, questi tutta l’incrollabile giustizia della Città universale» (Pico 1942, p. 307).
«Non vincolo del mondo, – ha scritto Eugenio Garin a proposito dell’omicciolo di Alberti – ma offesa e dolore del mondo, esprime l’assurdo e la follia della vita» (Garin 1975, p. 1535Garin, E. (1975) Rinascite e rivoluzioni, Roma-Bari: Laterza.), una follia generata dall’incoscienza di chi «volle solcare il mare e traghettarsi, credo, fuori del mondo; volle sotto acqua, sotto terra, entro a’ monti ogni cosa razzolare, e sforzossi andare sopra e’ nuvoli» (Alberti 2013). L’uomo del Theogenius è nemico di se stesso e della natura nella misura in cui è «il segno di una rottura dell’essere»; la stessa a cui costitutivamente è esposto il «grande miracolo» di Pico, con una differenza radicale: in Pico la libertà umana è lo spiraglio dal quale filtra un pur debole raggio di luce sulla tragicità dell’esistenza umana, mentre nel Teogenio, nel Momus e nelle Intercenali la durezza e l’inflessibilità del destino sembrano chiudere ogni spazio di salvezza.
«Distrutta la mediazione umana fra un cielo deserto di Dio e un mondo vuoto di ogni intervento provvidenziale, restituito alla sua miseria reale il mortale iddio felice, che cosa resta se non l’assurdo di forze cieche, di forme senza scopo, di eventi privi di senso?» (Garin 1975, p. 179). Qualcosa resta. Resta il senso dell’operare umano, seppur provvisorio, e resta la ricerca della virtù come unica prospettiva di senso possibile. La ricomposizione dell’ordine naturale delle cose, lacerato dall’hybris e dalle bassezze umane, dipende proprio dalla possibilità di un percorso morale che formi l’uomo nella sua interezza. L’esercizio della virtù è quindi il solo cammino possibile per ricomporre la frattura aperta tra l’uomo e se stesso, tra se stesso e la natura.