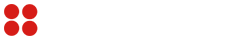Sullo sfondo rimaneva in tutta la sua radicalità il problema della relazione tra i linguaggi poetici e l’argomentare filosofico, vale a dire la gamma infinita delle interpretazioni possibili del testo e il rischio dell’inganno e del fraintendimento. In questo sforzo di svelare la dimensione filosofica e razionale dei linguaggi del mito e della poesia si capovolgeva però il rapporto con l’origine: nel mito Pico andava riscoprendo non più il punto fermo a cui ancorare un sapere già dato, non una specie di chiusura nell’identico che si tramanda per segrete vie ai più sapienti degli uomini, ma un ambito di investigazione razionale e autonoma attraverso la quale il filosofo si riappropria e riformula il passato con gli strumenti della storia, della filologia e del vaglio critico delle tradizioni.
Per Cassirer il neoplatonismo fiorentino aveva «ipostatizzato» le forme del mito, sovrapponendo a esse le strutture dell’interpretazione razionale e allegorica; solo con Giambattista Vico si sarebbe arrivati invece a concepire il mito come «una tendenza originaria dello spirito e un’autonoma facoltà formatrice della coscienza» (Cassirer 1923, p. 61Cassirer, E. (1923) Philosophie der symbolischen Formen, II: Das mythische Denken, Berlin: Bruno Cassirer (trad. it. 1964, Filosofia delle forme simboliche, II, Il pensiero mitico, Firenze: La Nuova Italia).). Sempre secondo Cassirer, Vico, prima di Hölderlin e Schelling, poteva essere considerato non solo come «il fondatore della moderna filosofia del linguaggio», ma anche come «il fondatore di una filosofia della mitologia completamente nuova» (Cassirer 1923, p. 6). È interessante notare come su almeno un punto l’interpretazione di Cassirer coincida con quella di un altro grande studioso della filosofia dell’umanesimo, Ernesto Grassi. Anche per Grassi infatti, sul tema del linguaggio e sul rapporto tra filosofia, mito e poesia, si dà un “salto” che va dal primo umanesimo a Vico, senza che in questa linea vi sia spazio per la riflessione elaborata dal platonismo fiorentino (Grassi 1983, p. 92Grassi, E. (1983) Heidegger and the Question of Renaissance Humanism. Four Studies, Binghamton N.Y.: Center for Medieval and Early Renaissance Studies.).
Ma è proprio con Pico che si compie con particolare intensità lo sforzo di razionalizzazione sottolineato da Cassirer. Il problema di decifrare il mito, razionalizzando, formulando il senso dell’allegoria, traducendo il simbolo in argomentazione logica, porta tuttavia Pico sulla via critica di un’interrogazione sui limiti dell’interpretazione filosofica. È questo uno dei risultati principali della nuova filosofia: l’interpretazione allegorica del mito – come ogni altra forma di discorso – viene subordinata alla riflessione sulle sue condizioni di possibilità e all’analisi dei diversi linguaggi, che la ricerca può legittimamente utilizzare. Se è vero che nei suoi tentativi di interpretare tanto la Genesi e i Salmi, quanto i grandi miti della letteratura classica Pico prosegue nella linea speculativo-allegorica del tipo di quella definita da Cassirer, è altrettanto vero che vi è un passaggio fondamentale dal problema del significato del mito a quello delle possibilità di significazione dei linguaggi della filosofia. E c’è un altro elemento di totale discontinuità: il tema dell’origine è ora declinato non come punto d’inizio di una tradizione, né come l’àncora alla quale fissare la storia umana, ma equivale piuttosto a una domanda volta a decifrare che cosa, nell’indiscreta natura umana, vi sia di stabile e cosa di cangiante. All’origine fissata agli albori di un tempo mitico si sostituiva allora la definizione della condizione originaria della natura umana, dalla quale derivare lo spettro delle sue possibilità realizzate e di quelle da realizzare.
Il racconto della creazione di Adamo disegna uno spazio eidetico che comprende ogni sfumatura dell’umano; in esso ogni cosa si colloca nelle due dimensioni dell’alto e del basso, dell’abisso e dell’angelo. Al centro di questo spazio simbolico Pico colloca Adamo, immagine e simbolo di una condizione pre-umana e indefinita. Questo è il punto teoreticamente più complesso di tutta la filosofia di Pico, quello in cui si gioca sia la questione della libertà umana, sia il rapporto tra micro e macrocosmo. Il principio diventava l’uomo inteso come «opus indiscretae imaginis», ovvero l’esatto opposto dell’arché immutabile pensato da Pletone. Alla necessità della prima determinazione ontologica, Pico opponeva un principio di totale indeterminatezza e libertà. Anche il motivo dell’origine veniva interpretato sotto una luce nuova, che non era più quella di una mitica cronologia, ma quella di un’antropologia rinnovata.
Il problema principale resta la ricerca di un fondamento per la validità dei saperi umani. Pletone lo aveva risolto in termini non molto diversi da quelli usati circa due secoli dopo da Descartes: un principio primo, una divinità posta a garanzia dell’armonia tra il conoscere umano e il cosmo, tra la razionalità del pensiero e quella della natura (Masai 1956, p. 128 ss.). Pico rovesciava l’ontologia di Pletone: se il problema dell’origine si risolve nella costitutiva indeterminatezza della natura umana, allora la corrispondenza tra pensiero e natura non può più derivare da Giove – da un Dio che tutto regge e tutto determina – ma può realizzarsi solo nell’operato di Adamo, nel suo scegliere, nel suo essere in grado di plasmare se stesso nel mondo. Da una parte le leggi della natura e del cosmo, dall’altra la libertà dell’uomo: «la natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio» (Pico 1942, p. 107).
Quello che emergeva di radicalmente diverso rispetto a Pletone – e a molta parte del dibattito sul platonismo di metà Quattrocento – era una visione dell’uomo finalmente libera dai principi di un’ontologia rigidamente determinista. L’uomo di Pletone stava al centro del migliore dei mondi possibili, l’Adamo di Pico invece era l’anomalia, il paradosso, il punto di crisi nella libera creazione divina e in un cosmo governato da leggi inderogabili. La celebrazione della libertà umana di Pico sembrerebbe quindi sacrificare ogni certezza, teologica e immanente, alla costitutiva indeterminatezza dell’umano. In realtà, come si è già più volte detto, è un punto di vista radicalmente nuovo quello che si faceva strada nel pensiero di Pico. La garanzia dell’armonia tra la natura e il pensiero non stava più in un terzo termine – il Giove di Pletone che tutto dirige – bensì nell’uomo stesso. Era la mente umana – e Pico è molto chiaro su questo, nell’Heptaplus – «il quarto mondo in cui si trova-no tutte le cose che sono negli altri» (Pico 1942, p. 300), ragione per la quale la conoscenza umana può bastare a se stessa: non c’è nessun ordine esterno da riflettere; fondamento di ogni ordine è l’essere umano che plasma se stesso e reforma la realtà, organizzandola in concetti. Per questo non serviva neppure un Dio a garanzia dell’armonia tra l’oggetto esterno e il pensiero.
Questo era il senso della teoria della conoscenza che Pico aveva esposto nel Commento: l’intelletto umano, «illuminato» dalle forme, coglie in sé l’ordine reale delle cose, un ordine che il soggetto stesso ha creato. Come si è già visto, nel Commento Pico aveva definito un itinerario conoscitivo diviso in gradi, nel primo dei quali, attraverso la visione sensibile, l’oggetto perviene ai sensi, nel secondo la facoltà dell’immaginazione “riforma” l’oggetto astraendo dalle caratteristiche sensibili, nel terzo la ragione trasforma la singola immagine in un concetto generale, infine, nel quarto grado, l’anima scopre che l’universalità del concetto deriva «non dallo obbietto esteriore sensibile, ma dallo intrinseco suo lume e sua virtù» (Pico 1942, p. 568).
Al Giove di Pletone e del determinismo (neo)platonico, Pico opponeva la libertà di Adamo associando le forme del sapere umano a una teoria della conoscenza che collega la verità ai meccanismi dell’immaginazione, della ragione e dell’intelletto, più che a quelli di un ordine preesistente in natura. Lo stesso mutamento avviene nel modo di intendere l’origine temporale del sapere. La concordia – il grande progetto di Pico di conciliare in un unico grande edificio del sapere tutte le tradizioni filosofiche del passato – trasformava il concetto di κοιναὶ ἔννοιαι che Pletone aveva ripreso dagli stoici (Masai 1956, p. 115 ss.): se vi era una comunanza tra le grandi filosofie del passato, questa non era già data, non derivava da un’origine remota e comune e non derivava neppure dalle forme di un’intuizione razionale superiore. La concordia, l’armonia dei saperi, era invece il prodotto finale degli stessi meccanismi conoscitivi attraverso i quali l’uomo si rapporta alla natura. Come l’esperienza empirica doveva essere guidata dai principi della ragione, allo stesso modo l’oggetto della storia della filosofia veniva sottoposto all’attività del soggetto e alle regole della ragione. Il dato meramente sensibile – indifferentemente l’osservazione delle stelle nelle Disputationes o la cortex verborum dei testi filosofici – doveva essere oltrepassato: nel caso della storia del pensiero il passaggio dalla discordia apparente, lessicale e di superficie, alla concordia philosophorum poteva avvenire solo con l’elaborazione di un punto di vista capace di interrogare il testo o addirittura di forzarlo consapevolmente. Questa è una caratteristica che si ripete nelle opere di Pico. «Ammettiamo pure – scriveva Pico alla fine del secondo capitolo del De Ente et Uno – che Platone abbia sostenuto una tesi che certamente non ha mai approvato. Esaminiamo allora come la si sarebbe potuta affermare a ragione, ponendo così i principi basilari della dottrina aristotelica» (Pico 2010, p. 215).
Era questo il nuovo metodo con cui Pico misurava la coerenza interna di una filosofia e il suo rapporto con tradizioni diverse. Al ritorno dell’identico subentrava dunque il compito di trarre dai testi del passato nuove significazioni e nuove disposizioni del sapere, la cui validità non dipendesse più né da un’origine temporale, né da un’origine divina, ma dal modo attraverso cui l’uomo poteva plasmare la propria conoscenza del mondo e sottometterla al vaglio mondano e critico del pubblico dibattito.