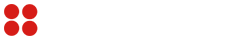La concinnitas del sermo, e cioè l’adeguatezza della parola, la sua intima esattezza o perfezione, la stessa eleganza che la lettera di Pico non disdegna affatto, consiste per lui, prima di tutto, nella trasparenza che ha rispetto alla cosa designata. E quell’armonia di ratio e oratio, di eloquenza e sapienza che non meno del suo interlocutore cerca di perseguire, sta nella adeguatezza che i vocaboli – le voces – stabiliscono, nella misura del possibile, con i concetti, i quali a propria volta devono riflettere, nella misura del possibile, le res, l’essenza stessa delle cose. C’è «un’inevitabile perdita di senso tra la cosa, il concetto e la parola, e il compito di un’eloquenza sapiente, o di una filosofia eloquente, è precisamente quello di governare quel gap, di ridurre quanto più possibile un pur ineliminabile deficit di autorità nel passaggio dalla cosa alla parola» (Angelini 2017b, p. 331Angelini, A. (2017b) Pico, Barbaro e i Sileni di Alcibiade: considerazioni sulla disputa de genere dicendi philosophorum. In: G. Ventura, a cura di, Pico tra cultura e letteratura dell’Umanesimo, Bologna: AlmaDL Acta, collana “Petali”.). Ma allora, se il linguaggio deve rispecchiare la realtà, perde d’importanza il rispetto della convenzione linguistica che invece Barbaro pretende: ciò che il filosofo deve pretendere dalla sua oratio è che essa sia conforme alla natura e, non necessariamente, in latino.
«Devi sapere – scrive Pico al suo corrispondente veneziano – che qualunque cosa io dica, è di gran lunga inferiore (longe esse minora) a ciò che io penso» e che «le mie parole sono tanto lontane (deesse) dal mio pensiero (animo), quanto il mio pensiero è lontano dalla realtà» (Pico, Barbaro 1998, p. 36). Tra cose, concetti e parole, Pico riconosce e quasi misura un preciso décalage. Se non è possibile annullare quell’inesorabile perdita di senso che accompagna la transizione dall’oggetto alla parola, ignorarla o dissimularla si rivela un vero e proprio errore filosofico. Sebbene il linguaggio trovi il proprio limite strutturale nell’inadeguatezza a cogliere il vero nella sua totalità, quello stesso limite può rivelarsi un espediente in vista della dissimulazione della verità. «Accade alla sapienza e agli argomenti dei filosofi: col belletto non diventano più splendenti, ma si offuscano» (Pico, Barbaro 1998, p. 55). Le verità più preziose rischiano di essere alterate da inutili ornamenti, mentre un involucro rude può rivelarsi una custodia sicura per un contenuto stabile, disvelato a pochi e ai più precluso. La ricercatezza del linguaggio e del discorso, lungi dall’essere latinissima, rischia di contraffare il pensiero e nascondere le cose, trovando assonanze laddove non ci sono e analogie ove sono le differenze. Al contrario, un eloquio non suadente né persuasivo, e tuttavia veicolo di verità, si rivela simile alle statuette dei Sileni descritte da Alcibiade nel Simposio di Platone, grezze all’esterno, eppure inattesi ricettacoli di gemme e di oggetti preziosi all’interno (Angelini 2017b, p. 27). «Vivo e vivente non è il linguaggio, ma una verità che si abbevera al fonte stesso della Vita e che scorre al di sotto delle voci e delle parole proferite nei secoli» (Angelini 2017b, p. 24); è questo, del resto, il motivo che ricorre nella seconda parte della Oratio de hominis dignitate e nell’Apologia, quello di una verità che la varietà degli stili, delle forme, delle grammatiche e delle figure attraverso le quali è stata trasmessa e difesa non mortifica, ma alimenta e fortifica «proprio come il muoversi del vento non spegne, ma piuttosto rinfocola la fiamma» (Pico 1942, p. 142). Ma il senso inditus rivendicato dal filosofo non è paragonabile a quello di un accordo musicale o di un’immagine, i quali, in virtù delle rispettive qualità sensibili, colpiscono l’udito e la vista (Pico, Barbaro 1998, p. 80). Per Pico il senso che la filosofia indica, così vivo e vivente da essere non solo immortale, come vorrebbe il grammatico, ma addirittura perennis, risiede nel suo attingere ai principi delle cose, riprodurre il ritmo della natura, penetrare fino nell’intimo della realtà. Un senso che trascende la storia e la funzione comunicativa e referenziale dei linguaggi parlati dagli uomini, completamente svincolato dal sentire umano, dal secolo e dalla missione civile e immanente di un’umanità eloquente. Il senso delle cose, nascosto nel Sileno di un’orazione sgraziata, è quello che tocca al filosofo riportare alla luce dissodando il terreno impervio, e non di rado forviante, delle parole e delle apparenze sensibili. L’insufficienza del linguaggio impone un’ulteriore integrazione del concetto stesso di concordia. La concordia che Pico ha in mente è più complessa da individuare rispetto a quanto indicato dalle comparationes dei suoi maestri, in quanto consiste nel riportare all’unità dell’antico splendore la sapienza offuscata dal «belletto» di cattivi interpreti. A questo scopo ciò che serve è il bisturi del linguaggio interiore (ἐν διαθέσει λόγον) e non di quello esteriore (τὸν ἐν προφορᾷ).
Si possono distinguere in Pico alcune precise tipologie di «offuscamento» e di dissimulazione del vero. C’è un nascondere che nasce dalla volontà deliberata di dire il falso, di giocare con le parole per ottenere un genere di consenso che prescinda totalmente dal valore veritativo di un ragionamento. Pico indica i modi in cui ciò avviene: il retore può «accrescere» o «sminuire» l’oggetto di cui tratta, tradendo in questo modo «la natura della cosa». In questo caso lo fa ingannando la mente degli uditori con parole che, una volta svuotate di contenuto veritativo, non sono che «fantasmi e simulacri» (Pico, Barbaro 1998, p. 55). È l’inganno dei retori, i quali mirano a una persuasione sia pure esteriore, diversamente dai filosofi, i quali si dedicano a conoscere e a mostrare agli altri la verità. Dissimulare però non significa necessariamente mentire. In certi casi l’«offuscamento» non è tradimento, ma custodia della verità affidata al respingente Sileno:
non diversamente dagli antichi che tenevano lontani gli indotti dai misteri con i loro enigmi e con gli integumenti delle favole, anche noi, siamo soliti allontanarli dalle nostre vivande, che essi non potrebbero non profanare, con una scorza verbale (cortex verborum) un po’ amarognola (Pico, Barbaro 1998, pp. 47-49).
Qualcosa di analogo, ma per ragioni diverse, fanno anche i grandi poeti.
Nell’Oratio, Pico scriveva che Omero avrebbe «dissimulato» sotto i viaggi di Ulisse, i fondamenti di tutte le scienze (Pico 1942, p. 150). Al poeta che «ai popoli mostra il volto degli dei» (Poliziano 19962Poliziano (1996) Silvae. Edizione a cura di F. Bausi. Firenze: Olschki.) si era rivolto anche il Poliziano, nello stesso 1485, dando pubblica lettura dell’Ambra. La parola poetica, vera “nutrice” dell’umanità, era per Poliziano la forza che per prima aveva alimentato le «caelestia semina flammae» di Prometeo, togliendo l’uomo da uno stato di natura rozzo e irrazionale per istruirlo alle leggi della società umana (Poliziano 1996, p. 284). Si è già detto come, nel campo della conoscenza della natura, l’errore originato dalla distanza che separa il linguaggio dalle cose, possa, per Pico, essere superato da un’osservazione diretta della natura e dall’esperienza condotta secondo principi razionali. Ma come si può scoprire la verità nascosta dietro la parola poetica? Come colmare quella distanza posta dalla dissimulazione poetica o dalla «cortex verborum» dei grandi sistemi filosofici?
Per adempire a tale compito a Pico serve non un linguaggio nuovo, ma una nova methodus philosophandi in grado di caricare su di sé e piegare all’indagine filosofica anche gli studi dei «grammatici». Lo studio delle grandi tradizioni filosofiche richiede in prima istanza uno strumento lessicale capace di guidare l’analisi linguistica e filologica. Proprio perché il linguaggio è storico e convenzionale, la filologia è la premessa per leggere in modo appropriato le fonti. Ma per recuperare il vero significato delle opere dei Prisci occorre congiungere agli studi dei grammatici una comprensione filosofica dei sistemi e delle dottrine, che permetta di definire i diversi contesti semantici, le strutture argomentative, la diversità dei punti di vista sulla base dei quali si afferma o si nega un determinato concetto. Lo strumento filologico non è sufficiente, giacché l’impegno del filosofo è quello di emendare il pensiero (mens) non l’espressione (dictio); la sua preoccupazione, nel sondare i meandri di una verità perenne, è che a deviare dalla via maestra sia la ragione (ratio) e non semplicemente l’orazione (oratio).
Vale la pena soffermarsi, a questo proposito, su un apparente paradosso: per comprendere il pensiero di un filosofo oltre la littera, può essere utile ipotizzare che egli abbia scritto cose diverse da quelle effettivamente tramandate. Tradirlo deliberatamente su un punto può essere un espediente efficace per misurare quanto sia chiaro il senso filosofico dell’intero sistema. Attenendoci alla coerenza stessa di quella filosofia, ripercorrendola e in un certo senso rivivendola, ecco che allora ne avremo una vera comprensione. Per questa via si può andare oltre la «corteccia» delle parole. Si tratta, in buona sostanza, di un’opera di chiarificazione concettuale che parte da un’analisi storica del linguaggio, chiarisce la molteplicità dei contenuti semantici di un concetto in relazione al sistema e, riconducendo ognuno di questi al proprio ambito specifico, permette di tenere insieme posizioni apparentemente distanti. Questo è il metodo indicato da Pico già nel suo Commento sopra una canzona de amore composta da Girolamo Benivieni. L’indicazione è importante anche perché il Commento è l’unico testo, a parte il riferimento contenuto nell’Oratio, che contiene elementi del progetto di una teologia poetica (Pico 2010, p. 65). Il primo capitolo del secondo libro del Commento è significativamente intitolato: «che ogni volta ch’el nome della cosa proposta è ambiguo, si debba prima presupporre quello che per tal nome si significhi». Nel manoscritto Estense K. I. 16 il titolo è «che regula s’ha a tenere nel tractare di qualunque materia».
Prima di trattare di qualsiasi argomento occorre innanzitutto stabilire se il nome che indica il concetto di cui ci occupiamo sia un nome «equivoco», vale a dire «significativo di cose diverse e varie». In questo caso diventa indispensabile «distinguere quei significati e dichiarare per quale principalmente noi l’abbiamo a usare». Se procedessimo altrimenti, cadremmo senza dubbio in una discussione «confusa, inordinata e vana» (Pico 1942, p. 485). E la discussione nel Commento procede coerentemente nell’individuazione dei diversi significati che il concetto di bellezza sottende. Nel De Ente et Uno Pico applicherà la stessa «regola» per distinguere i significati assunti dai termini “ente” e “essere”, affidando a quest’opera di chiarimento concettuale parte della dimostrazione della concordia Platonis et Aristotelis.
Ciò che Pico prescrive, sia che si tratti della bellezza, sia che si tratti dell’essenza, di Dio o degli angeli, degli accademici e dei peripatetici, è scomporre analiticamente i diversi significati di un concetto. La distanza tra parola e significato implica che talvolta s’intendano con lo stesso nome cose diverse e altre volte che si nomini una stessa cosa con termini diversi. Di qui gran parte di quella discordia, solo verbale, che oppone senza ragione le grandi tradizioni filosofiche. L’analisi delle molteplici significazioni sottese a un medesimo nome è lo strumento d’accesso al senso che sta dietro alla «corteccia delle parole» e che ci permette quindi di creare una corrispondenza tra tradizioni, pur propagate attraverso usi linguistici differenti.