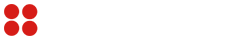L’idea di Pico di una «ragione al senso inclinata» segna il passaggio dalla visione dell’occhio all’uso dell’intelletto, dall’appetito che subisce la visione delle cose, al volere libero che ricostruisce in sé l’armonia delle idee. Un problema morale, prima ancora che gnoseologico, visto che la cecità incombe su tutto il processo: come la «Divina Caligo» e il silenzio del De Ente et Uno, così il limite della visione intellettuale nel Commento rimanda all’immagine ultima e non valicabile della conoscenza umana. Tiresia di fronte alla nudità di Pallade, Omero al cospetto dell’ombra di Achille, l’apostolo Paolo rapito al cielo: tutti scoprono nella cecità il limite ultimo della visione (Pico 1942, p. 529). L’immaginazione qui è centrale, perché non solo è «la più alta e più nobile potenzia del senso», ma è anche l’unica in grado di «reformare» la realtà: non la riproduce, la trasforma; non può ridurla a «perfetta immaterialità», ma può trasfigurarla e liberarla dalla «deformità della materia»:
dice el Poeta che sono da lei [dall’immaginazione] talor poi reformate, ma non però espresse, però che la immaginativa, come più alta e più nobile potenza del senso, di fuori fa quella specie più spirituale e conseguentemente più la spicca dalla deformità della materia, che seco non patisce la vera Venere, ma non può però, per essere lei pure potenzia ancora materiale e organica, redurre quella specie a perfetta immaterialità. Però dice che la reforma e non la esprime (Pico 1942, p. 577).
Il primo momento della conoscenza si dà nell’intuizione puramente sensibile dell’oggetto, il secondo determina il passaggio dagli occhi all’immagine formata dal soggetto che trattiene per sé non l’oggetto in quanto tale, bensì «l’immagine che nell’anima sua ha già di lui formata». Nel terzo grado la ragione trasforma l’immagine in un «universale concetto», infine il soggetto contempla in sé il molteplice ridotto a unità:
è che l’anima, surgendo sopra el primo e secondo grado, l’uno e l’altro de’ quali particularmente la bellezza considerando dalla materia non si spoglia, in universale concetto essa natura in sé considera e la multitudine di tutti e’ particulari corpi belli nella unità della bellezza in sé reduce (Pico 1942, p. 579).
Anche a proposito della facoltà immaginativa, Pico mette insieme l’idea aristotelica di una phantasia successiva al senso, alla quale è demandato il compito di interpretare le sensazioni e i sensibili comuni, e quella neoplatonica, difesa da Proclo, Sinesio, Prisciano, caratterizzata da una potenza produttiva e non semplicemente riproduttiva e assimilativa. Va però detto che le riflessioni sull’immaginazione del Commento presentano analogie forti con la descrizione del processo “complicativo” dell’arte nel De mente di Cusano. L’immaginazione conserva una vis assimilativa che la collega alla sensibilità, ma a quella annette una più importante funzione produttiva, che la pone all’origine delle arti meccaniche e logiche e la colloca all’interno della mente stessa. Lì sta la forma semplice e non sensibile che l’artista imprime a una materia esteriore, trasformando la materia in qualcosa di diverso da quanto non sia attingibile, nella sua natura, da nessun senso (Angelini 2017a, p. 1571Angelini A. (2017a) Fantasia e immaginazione nel Rinascimento, Milano: Editrice Bibliografica.). Così come, nei Dialoghi dell’Idiota, si regola il costruttore di cucchiai, il quale ricava dalla propria mente un esemplare e quello trasferisce su un legno grezzo. Non imita né riproduce nessuna forma naturale, perché in natura non esiste un cucchiaio; ma sgrossa e scava la materia eliminando da quella ogni imperfezione ecceda la foggia del cucchiaio desiderato finché non riconosce, nel legno scavato e sgrossato, «la proporzione dovuta nella quale risplende la forma del cucchiaio». Nei Dialoghi dell’Idiota, come nel passo di Pico, la visione dell’oggetto è successiva e non precedente la produzione dell’immaginazione: «vedi così la forma del cucchiaio, semplice e non sensibile, risplendere nella proporzione raffigurata in questo pezzo di legno, come nella sua immagine» (Cusano 1972, pp. 468-4692Cusano, N. (1972) Opere Filosofiche. Edizione a cura di G. Federici Vescovini. Torino: Utet.).
È interessante notare qui i cambiamenti nel lessico che Pico usa nel Commento. Nel primo grado, quello che riguarda la visione sensibile, Pico utilizza il verbo «ricevere» e precisa che l’oggetto «perviene» agli occhi. L’immaginazione invece «riforma», ma è incapace di «ridurre» l’oggetto a perfetta immaterialità, solo la ratio «la moltitudine nella sua unità reduce». Solo nel passaggio dal terzo al quarto grado si vede la beltà vera: è l’intelletto che, «illuminato» dalle forme, coglie in sé l’ordine reale delle cose; un ordine prodotto dal soggetto che lo ha creato «riformando» e «riducendo». Infine è «considerando l’operazione sua» e guardando a se stesso, ovvero è riflettendo su tutto il processo conoscitivo, che il soggetto scopre che l’universalità dell’ordine delle cose è un prodotto del proprio conoscere e non una realtà esterna:
el quarto grado è che l’anima, considerando l’operazione sua, vede sè cognoscere la natura della bellezza universalmente come non ristretta ad alcuna particolarità, e cognosce che ogni cosa, che nella materia è fundata, è particulare, di che conclude questa universalità non dallo obbietto esteriore sensibile, ma dallo intrinseco suo lume e sua virtù procedere (Pico 1942, p. 568).
La riflessione scopre finalmente in sé l’ordine delle cose, non però come necessità naturale e come esito di una causalità esterna, ma come prodotto del soggetto. L’intelletto, rimasto legato all’esperienza sensibile da cui ha preso avvio tutto il processo conoscitivo, se ne allontana per accedere alla pura visione della verità – «non però con totale plenitudine della sua beltà» – e al grado, ulteriore, della pura contemplazione del bene. Nel momento in cui l’intelletto è completamente slegato dall’esperienza sensibile cessa l’eros della conoscenza e la ricerca trova pace: qui «termina il suo cammino, né gli è licito nel settimo, quasi sabbato del celeste amore, muoversi più oltre» (Pico 1942, p. 5693Pico, G. (1942) De Hominis dignitate, Heptaplus, De Ente et Uno e scritti vari. Edizione a cura di E. Garin. Firenze: Vallecchi.).
La conoscenza puramente intellettuale in cui culmina il processo gnoseologico descritto da Pico può però solo essere «gustata quanto si può in questo mondo». A differenza di Ficino, Pico intende anche la bellezza come contesa, l’eros come ricerca infinita, la purezza della contemplazione come un limite che sta oltre la vita umana. Per Ficino la Bellezza è principio produttivo di amore: «e questa spezie divina, cioè Bellezza, in tutte le cose lo Amore, cioé desiderio di sé, ha procreato» (Ficino 2003, p. 304Ficino, M. (2003) Sopra lo amore ovvero Convito di Platone, Milano: SE.). Per Pico invece «la bellezza è causa dello amore, non come principio produttivo d’esso atto che è amore, ma come obbietto» (Pico 1942, p. 499). Seguendo la mistica cristiana Ficino pensa a un movimento circolare in cui la bellezza di Dio crea l’amore che «da Dio comincia e nel mondo trapassa, e finalmente in Dio termina». Pico invece, seguendo il Simposio, intende un percorso a senso unico che va dall’uomo all’infinito: in Dio non c’è bellezza «perché la bellezza include sempre in sé qualche imperfezione» (Pico 1942, p. 495). Non c’è neppure amore perché «non essendo in Dio desiderio di cosa alcuna fuora di lui, come quello in tutto è perfettissimo e nulla gli manca, non potria a lui più repugnare questo nome» (Pico 1942, p. 488). Lo scarto tra queste due concezioni sta esattamente nel modo di intendere il rapporto tra finito e infinito: per Ficino non c’è sproporzione, non c’è abisso, ma una sorta di continuità – “circolare” appunto – che pone l’uomo in continuità con il divino. Per Pico è il contrario: non potrebbe esserci distanza più radicale: l’uomo è Eros, ricerca inquieta, mentre Dio è pace e possesso pieno della verità; l’uomo ama il bello che è fatto di contraddizione è «amica inimicizia» o «concorde discordia», l’infinito invece assorbe e annulla in sé ogni contraddittorietà.
L’unione mistica con la perfetta bellezza intellettuale, la visione piena della verità, la pace e il riposo della ricerca non appartengono però – secondo Pico – alla vita dell’uomo; ne costituiscono l’orizzonte e la speranza, ne segnano il limite estremo, ma si rivelano solo come note in contrappunto rispetto alla melodia dell’incertezza, del dubbio e della contesa, che caratterizzano il mondo umano e la natura. Non ama perfettamente e non raggiunge la pienezza dell’intelletto «chi d’amore non muore».
È adunque l’intenzione di Platone di dimostrare come per alcuna via non sia da sperare di potere aggiugnere alla fruizione della intellettuale bellezza, se prima in tutto le inferiori potenzie abbandonando, la umana vita insieme con quelle non si abbandona; nè ama perfettamente, cioè d’amore perfetto, chi per amore non muore (Pico 1942, p. 555).
È questa la colpa di Orfeo, quella che Ficino non comprende: non volle andare «per morte» da Euridice ed è per questo che l’incantatore per eccellenza, il poeta figlio della musa Calliope, raccoglie solo l’ombra, solo un simulacro della verità.
Orfeo […] desiderando andare a vedere l’amata Euridice, non volse andargli per morte, come molle e effeminato dalla musica sua, ma cercò modo di andargli vivo, e perciò dice Platone che non poté conseguire la vera Euridice, ma solo un’ombra e uno fantasma di lei gli fu dimostrato (Pico 1942, p. 556).
In questa tensione sta l’idea di filosofia di Pico: determinare il passaggio dalla parola al silenzio, dalla visione alla cecità, dalla brutalità in cui può cadere l’uomo alla spinta che può farne un angelo. Anche qui è emblematico lo scarto lessicale che accompagna il passaggio da una conoscenza che collega il senso e l’immaginazione alla ragione e all’intelletto – l’unica che l’uomo possieda veramente – a una conoscenza puramente intellettuale e aliena alla ragione e all’esperienza. Il verbo ora è «spiccare»: «né altrimenti accade a chi crede – scrive Pico nel Commento – non si spiccando dalle operazioni della immaginativa e della parte eziandio razionale, adiungere alla vera cognizione delle intellettuale idee».
“Spiccare” dalle operazioni di senso e ragione significa però morire, essendo che «el moto e la operazione è segno di vita, la privazione di questi è segno di morte» (Pico 1942, p. 554). L’immagine del limite ultimo della condizione e della debolezza umana – tesa in uno slancio eroico verso la verità, un’immagine simmetrica e contraria alla codardia di Orfeo – è quella della morte di Alceste:
però Alceste perfettamente amò, che all’amato andare volse per morte, e morendo per amore fu per la grazie delli Dei a vita restituita, cioè regenerata in vita, non per corporale ma per spirituale regenerazione (Pico 1942, p. 555).
Prima di raggiungere questo limite il sapere umano può rivolgersi alla natura ed estendersi a ogni campo, forte di uno strumento, quello della ragione, capace di guidare l’esperienza e di farne astrazione e giungere a un grado di verità che, di fatto, è il più alto concesso alla natura dell’uomo.