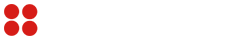Nel De beryllo, scritto che Pico avrebbe avuto tra le mani, si distingue tra l’Uno «assoluto» e l’Uno «con qualcosa di aggiunto» e, riprendendo la stessa considerazione del capitolo V del primo libro delle Congetture – in cui affermava che «all’unità ineffabile spetta meglio il nome di uno che un altro nome» – Cusano ribadisce:
sembra che a Dio si adatti meglio il nome di “uno” che un altro nome. Così lo chiamava Parmenide. Ugualmente Anassagora che diceva “meglio l’uno che il tutto”. Non devi intenderlo, però, come l’uno numerico che prende il nome di monade o singolare, ma come l’uno non divisibile da nessun modo di divisione e che è conosciuto senza nessuna dualità. Tutte le cose che sono dopo di lui non possono essere, né essere concepite, senza la dualità, perché prima di tutto c’è l’uno assoluto di cui si è già parlato; e, poi, c’è l’uno con qualcosa di aggiunto, cioè “uno ente”, “una sostanza”. E così di tutto. Pertanto non c’è niente che possa essere espresso o pensato così semplice da non essere l’uno con qualcosa di aggiunto, se si esclude l’uno sopraesaltato. Perciò vedi che Dio deve essere chiamato con i nomi di tutte le cose e con quello di nessuno – come diceva a proposito di lui Ermete Trismegisto (Cusano 1972, pp. 650-651).
Nel De coniecturis Cusano aveva parlato di quattro unità che la mente si rappresenta con nomi diversi: chiama Dio la prima, «altissima e semplicissima»; intelligenza la seconda, «che può essere la radice che non ha nessuna radice prima di sé»; la terza la chiama “anima” o “ragione” ed è «contrazione dell’intelligenza»; infine l’ultima è il corpo, «pesante solidità esplicata e che non complica nient’altro» (Cusano 1972). Affermare «che tutte le cose in Dio sono Dio – proseguiva Cusano – nell’intelligenza intelletto, e nell’anima anima, nel corpo corpo, non significa altro dal dire che la mente abbraccia tutte le cose o in modo divino, o secondo l’intelletto, o secondo l’anima, o secondo il corpo» (Cusano 1972, pp. 212-213).
Alle quattro unità corrispondono altrettanti piani diversi del conoscere e al vertice della gerarchia dei modi della conoscenza – non una scala ontologica, ma, per così dire, esistenziale – sta la sapienza dell’Idiota: non un riconoscersi ignorante con vena scettica né per umile rinuncia, ma per avere coscienza dell’insufficienza di ciò che la ragione distingue e che l’intelletto esplica (Cusano 2003, p. XVII1Cusano, N. (2003) I dialoghi dell’idiota. Libri quattro. Introduzione, traduzione e note a cura di G. Federici Vescovini. Firenze: Olschki.).
Al di sotto della sapienza dell’Idiota sta la comprensione intellettuale della coincidenza degli opposti nell’Uno, poi i sottili discrimini della ratio e infine i sensi. La prima unità è «anteriore anche a ogni diversità, alterità, opposizione, ineguaglianza, divisione e a tutto ciò che va insieme alla molteplicità» (Cusano 2003, p. 213). Nel descrivere la prima unità Cusano si esprime in un modo vicino a quello che Pico sceglierà quando andrà ad affermare che «ogni mente che cerca e indaga esige la luce di questa unità e non c’è questione che non la presupponga» (Cusano 2003, p. 214). Nel De coniecturis Cusano aveva scritto che, una volta considerato Dio come prima unità assoluta, allora «a ogni questione formulabile su Dio si può rispondere affermando che qualunque questione su di lui è stolta» (Cusano 1972, p. 215). Il concetto più assoluto della verità è pertanto «quello che trascura entrambi gli opposti, sia simultaneamente separati, sia uniti»; non si tratta né di un concetto di ragione, né di un concetto intellettuale: il punto è che per Cusano «non si potrebbe rispondere alla questione se Dio è in modo più infinito se non dicendo che Dio non è né non è, o che è e non è». (Cusano 1972, p. 216).
Il cardine dell’argomentazione del De Ente et Uno sta, come si è visto, nel dimostrare come Dio sopporti tanto i nomi di mente e intelletto, quanto quelli di vita e sapienza, pur collocandosi al di sopra della mente e dell’intelletto, della vita e della sapienza. Parimenti anche la problematica dell’Uno e dell’Essere rientra nell’ambito di una riflessione in ordine alla correttezza maggiore o minore di nomi attribuiti a Dio. In senso esistenziale Dio è (e in questo senso l’essere è il concetto communius); ma ciò non basta a determinarlo come un Essere, ragione per la quale il termine Uno si presta meglio all’esigenza di definire il modo in cui Dio è. E questo, per la stessa ragione per la quale Cusano aveva preferito per Dio il nome di Uno, non per consegnare a Dio una particolare “quiddità” (quella di unità) che lo distingua da tutte le altre, ma perché l’unità assoluta di Dio precede ogni distinzione.
Anche il nucleo del De Ente et Uno propone piani logico-argomentativi differenti, secondo i quali discorsi contrari diventano sostenibili. Su questa pluralità dei piani si giocano i rapporti tra la teologia negativa e quella affermativa, ma anche la questione centrale della definizione delle possibilità conoscitive dell’uomo rispetto a Dio e quella dell’interpretazione del concetto dell’Uno. La medesima istanza, a ben vedere, che guida il primo libro delle Congetture:
se a proposito dell’unità, che è una, tu parli quasi come di un’altra, tu l’adatti a questo modo di parlare, per cui quando parliamo di Dio da uomini razionali, sottoponiamo Dio alle leggi della ragione al punto da affermare di Dio alcune cose, negarne altre e applicargli disgiuntivamente gli opposti. Questo è pressoché l’indirizzo di tutti i teologi moderni che parlano di Dio con la ragione. Secondo questo indirizzo, ammettiamo molte cose nella scuola della ragione che, sappiamo, sono, invece, da negarsi nella regione dell’unità semplice (Cusano 1972, p. 223).
Anche nelle Conclusiones Pico insiste sui rapporti tra intelletto, ragione e conoscenza di Dio confermando una sintonia con i motivi delle Congetture: tre delle Conclusiones paradoxe numero LXXI meritano un’attenzione particolare:
- 1) «chi accede ad una realtà per via di definizione (in diffinitione), vi accede in termini di alterità (in alteritate)»;
- 2) «solo chi accede ad una realtà nella precisa distinzione della sua unità (in precisione suae unionis), accede alla realtà come essa è in se stessa (rem ut est ipsa);
- 3) «la conoscenza (cognitio) ottenuta per via dimostrativa (per demostrationem) è per l’Uomo, nella comune condizione (pro communi statu) di cui facciamo esperienza nel mondo, la più perfetta; ma presa in sé è la più imperfetta tra le conoscenze» (Pico 1995, p. 792Pico, G. (1995) Conclusiones nongentae. Le novecento tesi dell’anno 1486. Edizione a cura di A. Biondi. Firenze: Olschki.).
Attraverso la distinzione di piani diversi del conoscere Pico traccia una gerarchia che distingue un conoscere per definizione (tesi 1) che avviene nel rapporto con l’alterità, diverso dal conoscere nell’unità (tesi 2) che invece coglie la realtà com’è in se stessa. Normalmente (pro communi statu), la conoscenza umana che procede per distinzioni è la più perfetta, ma, considerata nel rapporto con altre forme e altri oggetti di conoscenza, essa si rivela essere «imperfectissima» (tesi 3). È il caso della conoscenza di Dio, poiché, secondo Pico, «l’infinità di Dio si può provare attraverso il di più con cui essa eccede l’essere intellettuale e attraverso la via della teologia mistica: ogni altra via è inefficace per tale dimostrazione» (Pico 1995, p. 83).
Ma, al di là di assonanze che lasciano intendere, come ha segnalato Kurt Flash, non solo la comune mediazione dionisiana, ma la lettura, da parte di Pico, di scritti di Cusano, ciò che più interessa, nel quadro dell’architettura concordista pichiana, è riconoscere come, anche nelle Conclusiones e nel De Ente et Uno, la riflessione su Dio si rispecchi, o addirittura si converta, in un discorso sul modo di conoscere Dio; come a dire che l’indagine teologica, anziché risolversi, alla maniera scolastica o alla maniera del Cittadini, in una costruzione logica o dialettica che adombra un’opzione ontologica, si converte di uno schema gnoseologico al quale è sottesa una precisa antropologia.
È in questo preciso ambito, quello di una riflessione critica in ordine alla conoscenza e, quindi, in ordine all’uomo, che si fonda il discorso sulla possibilità di una concordia tra tradizioni di pensiero differenti. Di fronte a discorsi diversi non viene semplicemente limitato l’ambito di validità di una fonte a preferenza delle altre – Aristotele per la fisica e Platone per la teologia – e neppure si tenta un’omologazione delle tradizioni che riconduce un’auctoritas a un’altra, negando diversità concettuali, storiche, soggettive.
Se il termine ultimo verso il quale la ricerca tende – il bersaglio all’infinito delle Congetture di Cusano – è irraggiungibile e ineffabile, allora ogni argomentazione che i filosofi e i teologi hanno tentato rappresenterà un passo verso la conoscenza, ma non una conoscenza raggiunta e acquisita. In questo continuo tendere di prospettive diverse, lungo strade diverse e non omologabili, verso un’unica, irraggiungibile, meta, sta la condizione di realizzabilità del modello di concordia. È infatti nel comune tendere all’inconoscibile che tutte le vie si incontrano, distinguendosi nel percorso che seguono, ma non nella meta che si danno. A dividere i percorsi è la diversità stessa che induce gli uomini a tentare processi differenti, segnati da concetti e intendimenti diversi. Una volta chiarite le differenti prospettive, si rivelerà per tutti quella medesima tensione, segno dell’unità d’intenti più profonda, che sta alla base delle diverse filosofie e che ne determina tratti comuni, imprescindibili. Di fronte a questo più profondo incontro, solo i dettagli restano in contrasto, a testimonianza dei diversi modi di tendere alla verità.
Il compito del filosofo che dispone di uno strumento per accedere non all’unità infinita, inaccessibile, ma alle principali tradizioni attraverso le quali, storicamente, le è stata data la caccia, è quello di tracciare il profilo di quella comune umanità che, attraverso l’insufficienza dei pur diversi tentativi di conoscenza, riconosce quella tensione verso l’infinito che è il vestigium dell’infinità divina nella particolarità, finita, determinata, parziale, degli individui. Una volta tracciato quel profilo, che non è né quello di Platone, né quello di Aristotele, non quello degli Accademici, né degli scolastici, dei logici o dei mistici, bensì quello della mens, la concordia philosophorum et theologorum sarà evidente nelle pieghe di un nuova filosofia, capace di abbracciare in sé i diversi punti di vista, non nella subordinazione, ma in una più alta comprensione.
La concordia, come si è visto, equivale all’edificazione di un nuovo edificio del sapere capace di comprendere tutte le grandi tradizioni filosofiche. Per costruirlo occorre un criterio di verità in grado di strutturarlo in maniera solida e adeguata. Né l’antichità di una tradizione, né, tantomeno, il principio di autorità possono però servire a organizzare un sistema capace di tenere insieme tutte le grandi filosofie del passato. Neppure nell’accordo che Pico va cercando tra le diverse filosofie si rivela un criterio sufficiente. È necessario, perché serve da un lato a giustificare la presenza di tradizioni diverse entro il nuovo edificio, dall’altro a definirne il grado di verità probabile, ferma restando la specificità irriducibile di ogni tradizione che Pico non solo non nega, ma studia e difende. Questi elementi sono alla base della concezione di filosofia che Pico difende nell’Oratio, ove afferma che «non può scegliere fra tutte la sua via, chi prima non le ha esaminate a fondo tutte» e aggiunge che «in ogni scuola v’è qualcosa di egregio che non le è comune con la altre» (Pico 1942, p. 141). Ma ancora questo non basterebbe a realizzare il programma di concordia discors, se si desse, anche per Pico, una filosofia perennis. Non è la filosofia, ma il fare filosofia che equivale a intraprendere una perenne ricerca dalla quale emerge una verità unica, ma camaleontica. Una verità che rimane un arcanum dei, ma che, tradotta in ricerca, in congettura, in sapere, è figlia dell’uomo e del tempo.
Nella sua assoluta pienezza e indeterminatezza è inesauribile dal sapere umano, costretto ai limiti del finito: cerchio e poligono per Cusano, creatore e creatura per Pico. Ma nel gap, ineliminabile, che distingue qualunque poligono dall’unico poligono d’infiniti lati, qualunque creatura dal solo Pantocrator che la ha posta in essere, si nasconde non un’essenza, ma un’attività, anch’essa inesauribile e, dunque, apparentata al divino. È in quello scarto che il Dio creatore dell’Oratio scopre la necessità di fabbricare una creatura affidata alla propria stessa libertà; ed è lì che l’uomo, nel riconoscersi «di natura indefinita», scopre la propria dignità. Quel riconoscere l’eccellenza di sé nel limite è il criterio che regge l’edificio della concordia: la struttura di una nuova antropologia prima ancora di quella di una nuova filosofia.