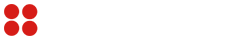«Il problema fondamentale della “libertà” e della “necessità” entra in una fase nuova», scriveva Ernst Cassirer a proposito del mirabile incontro, nel Rinascimento, di teoria dell’arte e scienze della misura, incarnato dalla figura dell’Idiota di Cusano. Anche per l’«architectus Deus» di Pico e per quell’opus indiscretae imaginis che è l’uomo, «l’antinomia libertà-necessità si tramuta in una correlazione», cosicché «nella necessità dell’oggetto l’io si riconosce, conosce le forze e la direzione della sua spontaneità» (Cassirer 1927, pp. 226-2271Cassirer, E. (1927) Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig: Teubner (trad. it. 1935, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, Firenze: La Nuova Italia).). La presa di coscienza di un’originaria funzione formatrice determina, anche nella prospettiva pichiana e nel suo “irregolare concordismo”, un nuovo concetto di natura e di legge naturale: non il puro opposto alla libertà dell’io, ma, per usare ancora Cassirer, «il termine, al quale sono dirette tutte le forze produttive, tutte le forze veramente attive dell’io, e nel quale esse trovano il loro proprio e concreto inveramento».
Nelle Leggi Pletone chiariva il nesso tra lo spazio dell’agire morale e la duplicità ontologica dell’uomo: «è impossibile che l’uomo non pecchi mai, poiché è composto da due nature, una divina, e l’altra mortale» (Pléthon 1966, p. 772Pléthon, G. G. (1966) Traité des Lois, Amsterdam: A. M. Hakkert Editeur.). Secondo il filosofo di Mistrà l’uomo, in virtù della duplicità ontologica che lo caratterizza, è in grado di partecipare e quindi di conoscere il divino. L’uomo ha una natura umana e una natura divina. La sua libertà è conformità all’ordine che governa il tutto ed egli è capace di raggiungere con la ragione la verità, la conoscenza del Bene e delle cose più alte:
Sebbene la natura divina sia estremamente al di sopra di quella dell’uomo, non si può dire per questo che l’uomo sia condannato a non conoscerla, poiché possiede la ragione e delle facoltà che non sono del tutto estranee alla natura divina (Pléthon 1966, pp. 42-43).
Se l’uomo pecca è per ignoranza; ma il male che commette non può intaccare l’ordine che regge il cosmo e la storia; non ne pregiudica la salvezza, perché anche il peccare si inserisce in un disegno provvidenziale che interviene a correggere l’esito delle azioni umane: «tutti gli avvenimenti futuri sono fissati dall’eternità, sono posti nel miglior ordine possibile sotto l’autorità di Giove, signore unico e supremo di tutte le cose» (Pléthon 1966, pp. 66-67).
Nell’Oratio di Pico la critica al determinismo di Pletone è tanto netta da mettere in discussione la stessa inflessibilità del piano provvidenziale. L’uomo non è una creatura ancipite, ma semplicemente non-definita, indeterminata (indiscreta); la sua libertà è dedotta dalla sua indeterminatezza ontologica, la quale corrisponde, quantomeno lessicalmente, a un verbo di conoscenza. Più paradossalmente, Pico deduce la libertà umana: a) da un bisogno di Dio (che vi sia un «universi contemplator»), b) da un’imprevidenza del Creatore («consilii inopia»). Questa la successione delle tappe de producendo homine:
Già il Sommo Padre, Dio Creatore, aveva foggiato secondo le leggi di un’arcana sapienza questa dimora del mondo […]. Senonché, conclusa l’opera, all’artefice mancava qualcuno che fosse capace di comprendere appieno (perpenderet) la ragione di un’opera così grande […]. Perciò, portata a termine ogni cosa (come attestano Mosè e Timeo), pensò da ultimo a produrre l’uomo (Pico 1942, p. 105).
Quasi un imprevisto, rispetto al piano originario del Creatore, e sicuramente una decisione tardiva rispetto alla ratio inderogabile e all’archana sapientia che ha guidato, fino a questo punto, la fabbrica della mundana domum, tanto che la precisazione che segue suona come un’autocritica divina, o peggio, come una critica espressa da una voce fuori campo, quella di un universi contemplator che ha addirittura l’ardire di giudicare l’opera somma del summus Pater architectus Deus e di metterne in evidenza l’avventatezza:
In verità, degli archetipi non ne restava nemmeno uno sul quale la nuova specie generata [soboles], né dei tesori almeno uno da elargire in eredità al nuovo figlio, né, in tutto il mondo, restava un posto libero sul quale potesse sedersi questo contemplatore dell’universo. Tutti erano già pieni, tutti erano stati assegnati, nei sommi, nei medi e negli infimi ordini (Pico 1942, p. 105).
Un’avventatezza, questa del sommo Padre, più simile all’imprevidenza del titano Epimeteo («colui che riflette tardivamente») che non alla saggia previdenza del fratello Prometeo («il preveggente», «colui che pensa in anticipo»), secondo il racconto del Protagora, dialogo che torna a più riprese centrale nella riflessione di Pico e nella sua idea di concordia. Tant’è che «non sarebbe stato degno della potestà del padre – rileva o suggerisce la voce fuori campo – rinunciare, quasi fosse divenuto sterile [effeta] di fronte all’ultima generazione [fetura]» (Pico 1942, p. 105).
Come rimediare? Il rimedio alla improvvidenza divina è l’indiscreta imago hominis. Il Creatore riprende allora la parola e, rivolto all’indefinita creatura, così proferisce:
Non ti ho dato, o mirabile Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell’aspetto, quelle prerogative che tu stesso desidererai, secondo il tuo desiderio e la tua decisione, tu le prenda per te […] Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, per tua stessa decisione [animi sententia], rigenerarti nelle cose superiori che sono divine (Pico 1942, pp. 105-107).
La duplicità ontologica dell’uomo, la sua capacità di partecipazione al divino si erano tradotte, in Pletone, nella celebrazione della ragione umana, capace di attingere alla definizione del vero bene e di imitarlo, inserendosi in un processo che tutto predispone e orienta verso il migliore dei mondi possibili. In Pico invece la natura dell’uomo non è ontologicamente doppia, bensì indeterminata, ove l’in-determinatezza corrisponde a un deficit (in privativo) di conoscenza (discerno). Tra i due poli, quello terrestre e quello celeste, sta la scelta libera del contemplator universi: necessariamente una scelta di conoscenza. L’indeterminatezza ontologica dell’uomo, il suo non essere «nec caelestem neque terrenum», insieme alla consapevolezza dei limiti della ragione umana definisce uno spazio per la libertà umana in cui al sogno di una filosofia della storia orientata verso il meglio subentra per l’uomo la scommessa e il peso della scelta. Pico non nega che tutto sia retto da un disegno provvidenziale; ma se in Pletone la necessità universale dei nessi causali chiariva una prospettiva rassicurante per l’uomo, ma incompatibile con la sua libertà, per Pico la provvidenza si articola su un piano di totale inconoscibilità. Si tratta di un problema centrale che, nelle Disputationes, getta una luce tragica su tutta l’antropologia pichiana: «noi omuncoli, anzi pipistrelli, talpe, asini, bovi piegati a terra, giudicheremo tutto ciò, chiamando in esame Dio stesso?» (Pico 1946, p. 4443Pico, G. (1946) Disputationes adversus astrologiam divinatricem. Edizione a cura di E. Garin. Firenze: Vallecchi.).
Ma il meraviglioso Adamo – il magnum miraculum dell’Asclepius celebrato nella Oratio de hominis dignitate sia «indiscretae opus imaginis» – è un limite della natura umana o piuttosto un limite dell’onniscienza del Creatore? È l’uomo che è incapace di discernere, o è Dio che, di fronte a una natura alla quale non è in grado di dare nulla che la distingua dalle altre, scopre un difetto della propria preveggenza? Si potrebbe dire che il nostrum chamaeleon, o, come preferirà dire Poliziano, il sacro animale uomo è un paradosso che segna semmai un punto di crisi entro il piano provvidenziale: libero dalla necessità naturale, ma costretto al proprio stesso arbitrio, Adamo non è (tanto) l’esito sommo della gratuita liberalità di Dio, quanto la conseguenza di un bisogno, di una mancanza, cui il Creatore, come Epimeteo (ἐπί μέδομαι) nel mito greco, riflette tardivamente. Perciò, mentre la libertà si realizza come effetto della necessitata indeterminatezza umana, la creazione di un opus indiscretum rivela una frattura nella previdenza o nella progettualità di Dio; un limite che, nelle intenzioni di Pico, non nega il precetto cristiano del rigoroso piano della causalità divina, ma certamente entra in una relazione dialettica con quello. L’intento pichiano non è anticristiano né irreligioso, e tuttavia la forte convinzione antideterministica adombra un vulnus entro l’onniscienza divina o quantomeno nella capacità di prevedere un ordine rigoroso, seppur trascendente, che guida oltre il caso e la fatalità degli accadimenti. Non solo: nell’imago indiscreta dell’universi contemplator si rispecchia un’immagine della divinità, la quale, di fronte a un’essenza che non può essere determinata né definita, opera una sorta di sospensione di giudizio e di afasia, analoghe a quelle imposte all’uomo dalla teologia negativa. Come l’uomo non può pronunciare il nome esatto di Dio né conoscerlo esaustivamente, così Dio non è in grado di discernere né di definire con precisione il miraculum magnum che si squaderna nel mezzo dell’universo.
La libertà dell’uomo consiste per Pico nella libertà di scegliere «se degenerare nel- le cose inferiori» oppure «rigenerarsi nelle cose superiori, che sono divine» (Pico 1942, pp. 105-107). Il processo di questa scelta, o meglio, di questa costrizione alla libertà, ricalca le tappe dei modi del conoscere dell’uomo sulle quali si strutturerà il De Ente et Uno. Alla mera sensibilità, che fa dell’uomo un bruto, seguono la ragione che ne fa un animale celeste, quindi l’intelletto in virtù del quale la creatura originariamente indefinita si trasforma in «angelo e figlio di Dio» (Pico 1942, p. 106). Con gli stessi accenti che caratterizzeranno il De Ente et Uno, anche l’Oratio accenna a quella «solitaria caligine del Padre» ove l’uomo può pervenire a un livello conoscitivo ulteriore, nel quale la sua libertà coincide infine con la realizzazione dell’unità dell’uomo con l’Assoluto:
Ma se, non contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, nella solitaria caligine del Padre colui che fu posto sopra tutte le cose starà sopra tutte le cose (Pico 1942, p. 106).
La filosofia di Pico afferma dunque un’idea di libertà assai poco trionfale, avvolta piuttosto nella consapevolezza tragica della condizione umana. Il legame tra il problema della libertà e la «divina caligo», l’incomprensibilità ultima e irriducibile contro la quale si scontra l’affannosa ricerca di senso dell’uomo, pone l’agire umano nella vertigine dell’incertezza e definisce al contempo l’impossibilità, per l’uomo, di giungere alla piena verità. Ciò che contraddistingue la condizione umana è il destino tragico dell’essere posto di fronte a un’opzione. Pur scegliendo la via della conoscenza e l’abbandono dei propri istinti, l’uomo intraprende un percorso la cui poco rassicurante meta è la consapevolezza dell’insufficienza del proprio conoscere (in-discernere), la scoperta che quell’itinerario che dovrebbe condurlo alla più piena felicità è qualcosa cui tendere all’infinito in un progresso di speranze più che di sapere. Ma è proprio la coscienza di questo limite, che è prima di tutto la coscienza dell’impossibilità di procedere affermativamente nella conoscenza piena dell’oggetto della propria ricerca, il momento di massima somiglianza con il divino: con una divinità che trova nell’uomo la faccia umbratile e oscura dell’onniscienza e della libertà.
L’uomo raggiunge la verità e la piena realizzazione della propria libertà solo in quanto altro da sé, come «unus cum deo spiritus factus». Proprio perché imago indiscreta, per Pico l’uomo, proprio come Dio, è tutte le cose; non però come principio, ma come termine medio. È questo il senso delle parole dell’Heptaplus: l’uomo «non è tanto un quarto mondo, quasi una creatura nuova, quanto il complesso e la sintesi dei tre mondi descritti» (Pico 1942, p. 301). Se Dio «contiene in sé tutto come principio di tutte le cose», l’uomo «contiene in sé tutto come termine medio di tutte le cose» (Pico 1942, p. 303).
Per Pletone, grazie alla ragione l’uomo poteva pervenire a una verità unica ed eterna, testimoniata dal comune accordo dei più antichi filosofi. Per Pico invece, il cammino verso la verità parte certamente dall’analisi dei filosofi antichi, ma, proprio perché la ricerca è infinita e le strade che si possono percorrere sono molteplici, è indispensabile tentare nuovi sentieri e nuove dimostrazioni.
C’è una domanda sottesa all’Oratio e, più in generale, ai propositi del giovane filosofo del tutto incompatibile con il pensiero di Pletone e con la concezione per la quale la verità va ricercata a ritroso, e il sapere integro, meta dei filosofi, è raggiungibile solo al termine di una revolutio verso il passato, l’origine, un’eternità che è prima del tempo: «a che serve – si chiede Pico – aver discusso tutte le altrui opinioni se, accedendo al convito dei sapienti come chi non rechi la sua parte, non avessimo portato nulla di nostro, nulla prodotto ed elaborato dal nostro ingegno?» (Pico 1942, pp. 142-145). La verità è una meta cui aspirare, è il limite ultimo cui tende il cammino di ricerca del filosofo nella consapevolezza del carattere provvisorio e particolare di ogni dottrina. Per questo la verità non è data una volta per tutte e non si esaurisce neppure nelle opere dei prisci Philosophi. Per possederla occorre riviverla e riguadagnarla lungo un percorso segnato più dall’inquietudine e dagli scontri che dalla calma della meditazione. Forse per questo, scriveva Pico, «anche i Caldei richiedono che alla nascita di colui che deve diventare filosofo Marte guardi con triangolare aspetto Mercurio, quasi che, tolte queste riunioni, questi contrasti, tutta la filosofia dovesse ridursi sonnacchiosa e dormiente» (Pico 1942, p. 137).